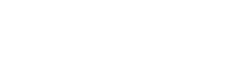- Marzo 30, 2016
Notizie
Ue – QEL Sole24Ore, la dimensione territoriale dei Fondi strutturali 2014-2020
di Giorgia Marinuzzi (*) e Walter Tortorella (*) ...di Giorgia Marinuzzi (*) e Walter Tortorella (*)
Il ciclo di programmazione dei fondi strutturali (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale-Fesr e Fondo Sociale Europeo-Fse) europei 2014-2020 è ufficialmente avviato da oltre un anno, tuttavia ci vorrà ancora del tempo per leggere dati significativi sull’attuazione ed avanzamento dei programmi/progetti. Ciò che invece è possibile analizzare sin da ora, alla luce dell’approvazione di tutti i Programmi Operativi dell’Italia, sono le allocazioni finanziarie e la dimensione programmatica territoriale che caratterizza i Po. A tal fine il Dipartimento Studi Economia Territoriale di Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) ha esaminato i singoli programmi, incentrandosi sulla ripartizione delle quote comunitarie tra le tipologie di territori bersaglio, previste dai Regolamenti dei Fondi Ue, e i meccanismi di erogazione territoriale (si veda l’appendice statistica).
Le risorse dei fondi strutturali 2014-2020
Le risorse a disposizione dei Programmi Operativi italiani che poggiano su Fesr e Fse 2014-2020 ammontano a oltre 51 miliardi di euro (rispetto al Pon Iniziativa Occupazione Giovani, che poggia su una dotazione complessiva di 1.513.363.329 euro è stata esclusa dall’analisi la quota ascrivibile all’allocazione specifica Yei – Youth Employment Initiative, del valore di 567.511.248 euro, mentre è stata considerata la restante quota di risorse riferita al Fse) , il 61% proveniente dal sostegno dell’Ue (pari a 31,2 miliardi di euro) ed il restante 39% dalla contropartita nazionale (20,1 miliardi di euro). La quota più ampia di tali risorse, pari al 65,4% (più di 33,5 miliardi di euro), è destinata alle regioni «meno sviluppate» del Paese, ossia Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, mentre la parte più ridotta, pari al 5,2%, alle 3 regioni «in transizione» e cioè Abruzzo, Molise e Sardegna. A metà strada, con una dotazione di 15 miliardi (il 29,3%) le restanti regioni, classificate con l’etichetta «più sviluppate». Oltre alle differenti assegnazioni, anche i tassi di cofinanziamento, calcolati come rapporto tra quota europea e dotazione complessiva del Programma, divergono tra le aree: il tasso si attesta al 50% per le regioni «in transizione» e «più sviluppate», mentre al 66% per quelle «meno sviluppate».
La dimensione territoriale dei programmi operativi
Rispetto ai 31 miliardi di euro di sostegno Ue è possibile leggere l’intenzione di destinare risorse a specifiche tipologie di territori da parte dei Po 2014-2020: a livello complessivo per il 53% delle assegnazioni non è previsto, in fase programmatoria, un territorio target, mentre le aree urbane grandi (con più di 50.000 abitanti, dette anche dai regolamenti Ue «densamente popolate») e piccole (tra 5.000 e 50.000 abitanti, dette anche dai regolamenti Ue «mediamente popolate») sono destinatarie rispettivamente del 27% e del 15% delle risorse. Alle aree rurali è indirizzato il 5% del sostegno finanziario europeo. In altre parole poco meno della metà delle risorse cadrà in territori ben definiti ed individuati, con le grandi città e le città medie che diventano di fatto potenziali driver di sviluppo, così come più volte ribadito in sede comunitaria ma senza che l’Italia nel corso di questi anni si sia mai dotata di una Agenda urbana nazionale. Poco più della metà, invece, sembra al momento libera da vincoli territoriali e più concentrata su politiche pubbliche trasversali. Tali proporzioni si modificano in base alle regioni prese in considerazione. In quelle «meno sviluppate» ad esempio si registra una chiara volontà di perimetrare il bersaglio territoriale degli interventi, convogliando quasi un terzo delle risorse Ue (30,3%) nelle aree densamente popolate, il 17% nelle aree mediamente popolate e circa il 6% in quelle rurali. All’opposto, le regioni «più sviluppate» preferiscono non legare il 70% delle risorse europee a specifiche categorie di territorio, optando invece di destinare il 17% dei finanziamenti alle grandi aree urbane, il 9,3% a quelle piccole e meno del 3% alle zone rurali. Una strategia ancora diversa si rileva per i Po delle regioni «in transizione», che si caratterizzano per la scelta di convogliare quasi l’11% delle quote Ue alle aree di campagna, un dato doppio rispetto alla media di tutti i Programmi. Che tutto ciò coincida con una strategia di policy delle singole regioni è auspicabile, che vi sia stata un’azione coordinata con una strategia nazionale non sembra, al momento, rilevarsi né nei fatti né nel risultato finale.
Per quanto concerne invece i meccanismi di erogazione territoriale delle risorse, il tratto comune a quasi tutti i Po riguarda la scelta di non prevedere strumenti specifici di attuazione: il 91% delle risorse non viene infatti ancorato a meccanismi predefiniti. Così dopo anni di discussione in merito all’invito da parte della Commissione al ricorso ad una nuova modalità di assegnazione finalizzata ad accorpare fondi di diversi assi prioritari di uno o più Programmi Operativi per interventi pluridimensionali o tra più settori, l’Iti per l’appunto, i soggetti programmatori sembrano abbiano accolto l’invito in maniera molto, molto tiepida, memori delle grandi criticità già affrontate in materia di programmazione integrata nel precedente ciclo 2007-2013. Nello specifico, si sbilanciano leggermente le regioni «meno sviluppate» e «in transizione», che programmano di ricorrere ad investimenti territoriali integrati per circa il 10% degli importi provenienti dall’Europa, un dato doppio rispetto al 4,6% delle regioni «più sviluppate».
(*) Dipartimento Studi Economia Territoriale Ifel