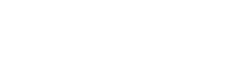- Novembre 15, 2017
Notizie
QEL Sole24Ore – Dalla Unificata parere positivo al documento «Posizione italiana del governo sulla politica di coesione post-2020»
di Francesco Monaco (*) Una breve premessa prima di entrare nel merito e per dar...
di Francesco Monaco (*)
Una breve premessa prima di entrare nel merito e per dare qualche elemento di contesto. A marzo di quest’anno, con la diffusione di un suo libro bianco (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf), la Commissione europea ha lanciato una grande riflessione sul futuro dell’Europa. Un pezzo importante di questa riflessione riguarda le finanze dell’Unione: la struttura del bilancio, la distribuzione delle risorse finanziarie tra politiche (politica agricola comune, coesione, reti Ten, ecc.), le regole di utilizzo.
A questa riflessione è associato l’avvio di un negoziato, che si annuncia duro, fra gli Stati membri e che dovrà scontare la fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione (Brexit), i cui effetti inevitabilmente si scaricheranno sulle dinamiche del confronto, sul disegno strategico che prefigura, sulle prospettive finanziarie che richiama.
La prima fase del negoziato si concluderà a metà dell’anno prossimo, con la formulazione di una proposta da parte della Commissione Ue sul futuro bilancio europeo. Proseguirà poi, per completarsi presumibilmente in coincidenza con la conclusione del ciclo 2014-2020, ma è chiaro che fin da oggi occorra prendere coscienza della posta in gioco e provare a influenzarne le scelte.
La partita sembra tecnica ma, in realtà, è squisitamente politica, perché tocca il cuore della riforma -non più rinviabile- dell’intero progetto europeo, riflettendone priorità e preferenze, degli Stati e delle popolazioni che decideranno di concorrervi.
L’importanza della politica di coesione
In questo quadro, la riforma della politica di coesione assume una sua centralità perché dà forma a una delle politiche più importanti e a vasto raggio dell’Unione europea: non è un caso che a essa sia attualmente dedicato circa un terzo del bilancio comunitario.
Questa politica rappresenta, nei fatti, una componente imprescindibile dei Trattati (e delle Costituzioni nazionali) ed è un pilastro fondamentale dell’integrazione europea.
La coesione, in ultima analisi, può contribuire a fermare l’erosione di fiducia dei cittadini nei confronti dell’Unione europea, offrendo loro nuove chance di lavoro e di benessere, oltre che assicurare la transizione verso un modello di sviluppo equo e sostenibile, in risposta ai molti e irrisolti problemi posti dalla globalizzazione (surriscaldamento del pianeta, inquinamento, allargamento delle ingiustizie sociali, nuove povertà, divisione internazionale del lavoro, ecc.).
Per tutti questi motivi è importante il parere positivo rilasciato giovedì scorso, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del Dlgs n. 281/1997, dalla Conferenza Unificata (CU) in merito al documento concernente la posizione italiana sulla politica di coesione post 2020.
Il documento ha, infatti, valore di atto di indirizzo politico dell’azione che il Governo dovrà svolgere nei prossimi mesi nel confronto con Commissione, Parlamento Ue, Consiglio europeo e Stati membri.
La posizione italiana
Il testo proposto dal Governo, oggetto – negli ultimi mesi – di ampio confronto politico fra Anci Regioni e Ministri competenti e migliorato in sede tecnica dal partenariato istituzionale, fissa alcuni principi negoziali fondamentali (se non irrinunciabili) per l’Italia.
Un primo principio posto è che il bilancio comunitario dovrà essere inteso come lo strumento principe per perseguire le priorità che l’Unione si darà da qui al 2030: i Paesi membri dovranno quindi trovare la forza di «portare avanti una politica di investimenti volta a favorire la convergenze dei diversi territori europei, quale bene comune europeo». In effetti, negli anni della grande crisi (2007-2014) i divari misurati in termini di Pil fra i diversi territori dell’Unione si sono allargati, amplificando considerevolmente i fenomeni di marginalità ed esclusione sociale, dei quali hanno maggiormente risentito le aree territoriali che strutturalmente registrano maggiori ritardi di crescita. L’Unione dovrà dunque impegnarsi più decisamente a colmare questi divari, orientando l’attenzione verso obiettivi di crescita economica e sociale, inclusiva e sostenibile, più che sul rispetto rigido dei parametri macro-economici. In quest’ottica, si renderà necessario superare anche il meccanismo della condizionalità macroeconomica (subordinare l’erogazione di fondi Ue al rispetto dei vincoli del Patto di stabilità), per «evitare che vengano messi a rischi investimenti proprio in quei territori caratterizzati da maggiori difficoltà strutturali».
Secondo principio cardine fissato nella posizione italiana è che la politica di coesione, con cui assicurare i maggiori investimenti pubblici richiesti dalla congiuntura europea, non solo dovrà «essere confermata e rilanciata come priorità dell’Unione» ma, al contempo, dovrà essere dotata di risorse adeguate anche nel post 2020, in misura «almeno pari a quella dell’attuale periodo di programmazione» e al netto degli effetti riduttivi che certamente Brexit produrrà nel futuro budget comunitario.
Un terzo principio è fissato nel «rispetto della rule of law, dei valori dei diritti fondamentali e delle regole di convivenza all’interno dell’Ue» quale condizione per usufruire degli aiuti europei. L’effetto voluto si otterrà inserendo specifiche clausole di controllo ex ante nell’erogazione degli aiuti, soprattutto in relazione all’osservanza dei principi di solidarietà nella gestione dei fenomeni migratori, la principale causa scatenante di tensioni sociali fra popoli (e gli Stati) europei dei prossimi anni.
Quarto principio riguarda infine «la concreta attuazione dell’aggiuntività delle risorse finanziarie della politica di coesione» rispetto alle politiche di investimento settoriali, europee e nazionali, anche tenuto conto dell’effettiva incidenza della coesione sulla spesa pubblica totale degli Stati membri.
Un principio largamente disatteso durante i lunghi della crisi, se pensiamo che in Italia, per esempio, secondo l’ultima Relazione annuale Cpt (http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/CPT/Temi/Temi_4_Rapporto_CPT_2017.pdf), la spesa pubblica “aggiuntiva” vale meno del 5% della spesa totale del settore pubblico allargato ed è comunque largamente “sostitutiva”, specie nel Mezzogiorno, di risorse capitali che il bilancio nazionale non riesce più ad assicurare.
Settori d’intervento e dimensione territoriale della coesione
Secondo il documento in parola, l’allocazione delle risorse della coesione dovrà «prevedere una concentrazione dell’intervento nelle aree in ritardo di sviluppo», sebbene nel quadro di «una politica rivolta a tutte le Regioni» e ai loro territori.
I settori strategici d’intervento sono definiti in continuità con il ciclo programmatico in corso e potranno spaziare dai piani di innovazione, ricerca e competitività delle imprese al potenziamento delle infrastrutture digitali, energetiche e di trasporto; dal perseguimento di un’efficace azione di contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici alla prevenzione delle fragilità territoriale; alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali e naturali, in un’ottica di gestione sostenibile; dal contrasto alla disoccupazione, in particolare quella giovanile, al potenziamento delle politiche attive per il lavoro; dalla lotta alla povertà per l’inclusione attiva dei cittadini all’accrescimento dell’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione; al miglioramento del contesto istituzionale e amministrativo.
Il tutto declinato, è questo è un punto decisivo, in chiave territoriale: dedicando cioè particolare attenzione alle aree urbane, rurale, interne e di montagna, «valorizzandone le potenzialità di sviluppo e capitalizzando le migliori esperienze in corso in questi ambiti, con uno sforzo finanziario specifico da parte di tutti i Fondi Sie (ndr: fondi di investimento europei: Fesr, Fse, Feoga, Fears)» nonché rafforzando l’approccio integrato place-based (ancorato al territorio) già sperimentato nel ciclo attuale di programmazione.
In questa chiara affermazione vi è la conferma (e il rafforzamento) dell’Agenda urbana nazionale (per le città metropolitane e le città medie) e della Strategia nazionale per le aree interne (per i comuni distanti dai poli di erogazione dei servizi fondamentali): le due principali policies di intervento territoriale dell’Accordo di partenariato 2014-2020, sulla cui attuazione occorre oggi concentrare l’attenzione di tutti i livelli istituzionali coinvolti per raccogliere i risultati attesi della programmazione.
Governance e struttura decisionale
Infine, la programmazione e gestione dei fondi. Fra le regole indicate nel documento, particolare enfasi è dedicata al tema del mantenimento di un orientamento ai risultati della politica di coesione. Un forte ancoraggio ai risultati, inteso in termini di miglioramento di tutti gli indicatori territoriali delle politiche di sviluppo (monitorati costantemente da Istat http://www.istat.it/it/archivio/16777), è fra le principali innovazione introdotte dai regolamenti vigenti e, se valorizzata attraverso la promozione di un ampio e partecipato dibattito pubblico, può costituire una della più formidabili leve di crescita istituzionale e democratica legate alla politica di coesione.
Un richiamo forte è dedicato inoltre alla semplificazione del sistema delle regole, assunta quale «condizione indispensabile per una gestione più efficiente delle risorse del bilancio comunitario».
Last but not least, il documento chiude recependo un’indicazione, fortemente voluta dal sistema delle autonomie, che conferma la validità del sistema di governo multilivello dei fondi e «che valorizza, accanto al ruolo dello Sato centrale, quello delle Regioni e delle autonomie locali».
(*) Capo Area Mezzogiorno e Politiche di coesione territoriale Anci