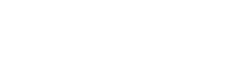- Giugno 12, 2017
Notizie
Libri – Un ben vivere nelle città che ci viene da lontano
Il ben fare di cui parla Dante in vari passi della Divina commedia (a testimoniare una vocazio... Il ben fare di cui parla Dante in vari passi della Divina commedia (a testimoniare una vocazione “civile” della nostra cultura) si declina oggi in un ben vivere che è al centro della riflessione sulla democrazia. Potremmo anche dire: una democrazia non funziona se le persone non sono in grado di badare a se stesse. Questo è l’assunto di un libro fondamentale per tutti i cittadini e specie per gli amministratori locali: Le città del ben-vivere. Il Manifesto programmatico dell’economia civile per le amministrazioni locali (Ecra, a cura di Leonardo Becchetti, pp. 331, euro 19).
Un libro-manifesto, composto da ben 45 contributi, che coinvolge esperienze e idee a proposito di pratiche sociali, forme di cittadinanza attiva e modelli di autorganizzazione. Una risposta concreta alla pericolosa seduzione dell’antipolitica proprio perché la politica si rifonda e si riqualifica a partire dalla sussidiarietà e dall’economia civile: le risposte ai nostri problemi non vanno interamente chieste al mercato e alle istituzioni. Sembra quasi che l’idea di un welfare dal basso, teorizzata dall’anarchico non-violento Colin Ward, ispiri molte di queste pagine. Il che ci permette anche di riannodare il legame tra politica e antropologia (“una idea meno angusta e limitante dell’uomo”), tra pragmatismo e utopia, non nel senso dello stato etico ma nel senso di una idea di felicità capace di orientare le nostre scelte, e radicalmente diversa da quella consistente nel consumo compulsivo e nell’arricchimento.
Nella presentazione Luigi Bobba ricostruisce meticolosamente il quadro del cosiddetto Terzo Settore, che nel nostro paese ha registrato una crescita straordinaria e che ha dimostrato anche una notevole capacità commerciale: un incremento del 28% degli organismi e del 39,4 degli addetti, e con quasi 5 milioni di volontari che prestano servizio gratuito. Dal welfare state si passa così alla welfare society: un principio di sussidiarietà orizzontale “che consenta al Pubblico di creare spazio per una società civile organizzata”. Sapendo che lo stesso sviluppo economico non dipende da un’unica forma di organizzazione delle attività economiche, da imprese che hanno come unico scopo la massimizzazione del profitto ( e che generano una economia instabile e disuguaglianze sociali sempre più laceranti). Con la legge delega del maggio 2016 il governo ha poi inteso riorganizzare la legislazione del Terzo Settore, per dare una “normativa concreta, utile ed efficace” a un “universo vasto e eterogeneo”.
Nella introduzione Stefano Zamagni si concentra sulla città come “campo spazialmente addensato di pratiche sociali ed economiche,”, come “ecosistema capace di ospitare e generare attività plurali e interdipendenti”, a partire dalla idea di civitas e dalla grande civiltà cittadina che fiorisce in Italia nell’XI secolo (l’università di Bologna nasce nel 1088): una città-comunità di uomini liberi, capaci di autogovernarsi, incentrata sulla piazza centrale, la cattedrale, il palazzo del governo, il palazzo dei mercanti e delle corporazioni, il mercato, i palazzi nobiliari e le chiese che ospitano le confraternite. La città come luogo ove si crea il capitale sociale, e dove si esercita quella particolare “beneficenza” cui alludeva Tocqueville, che “invita la società stessa a occuparsi delle avversità dei suoi membri e a provvedere in modo sistematico alla attenuazione delle loro sofferenze”. Questa è la nostra utopia concreta di smart city.
Impossibile riassumere anche solo approssimativamente gli innumerevoli contributi raccolti nel libro, di studiosi, professionisti, addetti ai lavori. Limitiamoci solo a scorrere i titoli dei capitoli, per avere almeno una idea della ricchezza di proposte e interventi: “Una nuova economia che genera lavoro”, “Una finanza e un fisco per lo sviluppo”, “Sensibilità e benessere”, Politiche sociali e di welfare generative e sussidiarie”, “Una nuova visione culturale e urbanistica”.
Torniamo a Tocqueville, citato da Zamagni: la democrazia si alimenta continuamente dell’associazionismo, della cooperazione, del volontariato, delle imprese sociali, della mutualità, di un tessuto sociale fatto di tanti intrecci relazionali, etc., insomma di tutti quei corpi intermedi in cui si formano cittadini responsabili e fraterni, non passivi, gelosi della propria autonomia, amanti del bello, capaci di autogoverno. Poi naturalmente lo stato e il mercato dovranno fare la loro parte. Almeno questo è l’insegnamento prezioso che ci viene dalla nostra stessa tradizione culturale e civile. (flp)