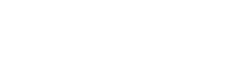- Dicembre 2, 2016
Notizie
Libri – Polis, per una decrescita intelligente della città. Intervista a Salvatore Di Liello
Di Liello è professore di Storia dell’archiettura all’università Federico ...Di Liello è professore di Storia dell’archiettura all’università Federico II di Napoli, ha scritto vari saggi sull’architettura (specie tra Cinque e Seicento) e sulla città, con particolare riferimento al paesaggio, tra natura e iconografia. Ricordiamo solo Il paesaggio nei Campi Flegrei. Tra realtà e metafora (2005) e Il castello Barbarossa di Anacapri (2004).
L’urbanizzazione. Il nostro pianeta sta sempre più urbanizzandosi: ormai, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di chi vive nelle città ha superato quello della popolazione rurale. E, se l’attuale tendenza sarà confermata, alla metà del secolo corrente circa i due terzi della popolazione vivrà in ambito urbano. . Come valuti questo fenomeno dell’urbanizzazione?
Nella riflessione sull’urbanizzazione mi sembra che abbiamo ereditato dal secolo scorso un’idea alimentata da contrasti, come sospesa tra il timore della scomparsa dell’idea di città e l’ansia di non riuscire a controllare la tendenza a una crescita smisurata di un organismo informe, difficile, quasi impossibile da decodificare. In attesa di valutare la ricaduta della rivoluzione informatica sulla forma, dimensione e soprattutto sul senso della città, si tratta oggi di riflettere sul “limite del possibile” dell’urbanesimo contemporaneo, un tema oggi al centro degli studi. Il culto della crescita incondizionata appare ormai in crisi, occorre invece muoversi oggi verso una decrescita intelligente delle città favorendo il risparmio delle risorse – il suolo tra queste – e un restringimento dei servizi, ripensando al valore primigenio della città ossia dell’arte delle distanze ridotte, al cui interno prende forma il fenomeno urbano (scambi, vita associata, politica…)
Non basta opporre il ‘no-sprawl’ allo ‘sprawl’. Non si tratta solo di contrastare la dispersione urbana, un modello di crescita urbana americano che ha mostrato esiti anche in Europa – penso a Barcellona – e in Italia, come mostrano gli studi sull’area metropolitana di Venezia, ma di ripensare al legame tra spazi, architetture e valore delle abitazioni, per evitare il disastro che in America ha determinato il fenomeno dei suburbs.
La questione del limite. Negli anni ’20 Le Corbusier pensava la modernità come espansione, mezzo secolo dopo Insolera dice che la modernità è sapersi fermare, è darsi un limite. Inoltre: una città deve avere dei confini, delle mura, o invece può fare a meno delle mura come del resto Atene nell’antichità? Nella città immaginaria di Zoe (nelle Città invisibili di Calvino) priva di qualsiasi confine, interno ed esterno, si finisce con lo smarrirsi.
La città può fare a meno delle mura, ma non dei confini, un “limite del possibile”, come accennavo, entro il quale trovano senso azioni e usi del suolo. Quando Filarete nel XV secolo fermava nel disegno di Sforzinda le aspirazioni della città ideale dell’Umanesimo antropocentrico, questa aveva un limite – il canale d’acqua e l’impianto stellare delle mura – al cui interno strade, piazze ed edifici modulavano il senso dei luoghi, armonicamente dimensionati e strutturati su una centralità intesa come metafora filosofica e politica di una nuova storia. Più tardi agli inizi della rivoluzione industriale, l’illuminismo riconosceva nella città il luogo dell’affermazione dei diritti umani. Si tratterebbe di valutare cosa sia accaduto nel tempo che ci separa da quelle definizioni. Durante il XX secolo, prendeva forma infatti l’elogio dell’espansione della forma urbana negli anni in cui l’urbanistica ufficiale, alimentata dai protagonisti dei CIAM, condizionavano gli architetti e gli urbanisti alla revisione critica della sedimentazione urbana nello specchio dell’idea lecorbusierana di fare nappe blanche della storia.
Il rapporto con il passato. Rapporto con il passato, con le opere architettoniche del passato, oscillante tra imbalsamazione e assenza di memoria: città come parco a tema per turisti, luogo di intrattenimento continuo (Las Vegas), i Grandi Eventi come riverniciatura superficiale ( e sostanziale indifferenza per la qualità urbana). Ad es. ritieni che il Comune dovrebbe fare qualcosa, salvare negozi e caffè di valore storico, imporre la cessione dei locali in affitto solo per certe destinazioni (una libreria), come del fanno a Parigi?)
La tutela della memoria urbana è un valore alto che non ha alcun rapporto con la museificazione dei nuclei storici delle città. Del resto, non basta restaurare con metodologia scientifica gli edifici storici, quando poi gli stessi vengono privati del senso per cui erano stati progettati, diventando appunto tessere, più o meno ‘sorprendenti’, più o meno monumentali, di un ‘parco a tema’, finto e mercificato, esposto a una fruizione turistica sempre più aggressiva. È una questione delicata e va affrontata caso per caso, nel rispetto di regole che non escludono l’eventuale trasformazione degli edifici e l’aggiornamento dei servizi sintomatici della contemporaneità: qualcosa di vicino al principio della “conservazione integrata”, enunciato fin dagli anni settanta del XX secolo, ma poco o male applicato. Ritengo che la città debba continuare il proprio racconto, riuscendo a esprimere un ‘oggi’ di scambi, attività e aspirazioni di una collettività. Salvare negozi storici, vincolandoli a determinate funzioni è giustissimo, ma rischia di non bastare se, ad esempio, l’incremento del valore economico dei suoli e degli immobili non è più sostenibile da tutti i ceti, ma solo da determinate gruppi sociali e/o imprenditoriali che rischierebbero anch’essi di trasformare i nuclei storici delle città in nuovi ‘parchi a tema’elitari. Insomma, la città storica deve continuare ad essere multi sociale e anche multietnica come documentano le numerose città storiche, tra quelle italiane penso a Palermo, Napoli, Roma, Venezia tra le altre.
La rappresentazione della città. Oggi occorre una nuova rappresentazione e un altro racconto per tentare di costruire una qualche idea comune e adeguata del vivere in città. Sappiamo che può essere fatto in tanti modi, scrivendo romanzi, saggi, producendo interpretazioni, raccontando semplicemente, costruendo filmati. Per Enzo Scandurra gli amministratori hanno spesso perso la possibilità di produrre una interpretazione adeguata alla realtà e si ostinano a produrre copie seducenti spacciandole per originali. Ma l’ “originale” è difficile da stanare…
Enzo Scandurra delle Vite periferiche racconta le conseguenze del liberismo sulla marginalizzazione di uomini e luoghi a Roma toccando la difficoltà di rappresentare la città contemporanea. Forse abbiamo bisogno della coralità dell’ arte e il suo irripetibile modo di trattenere il senso della Weltanschauung. Forse per avvicinarsi a un racconto della città più efficace probabilmente potrebbe aiutare provare a uscire dalle teorie, dagli studi urbanistici ed economici per affidarsi all’Arte. Penso a quel che fece il cinema d’avanguardia negli anni venti del Novecento, quando gli artisti si volsero alla rappresentazione filmica come possibilità di liberare l’arte dalla tela riuscendo a esprimere la temporalizzazione dello spazio che è propria della città. Più che alla metafora espressionista di Metropolis di Fritz Lang, mi riferisco a Walter Ruttmann che, nel suo Berlin, Die Sinfonie der Groβstadt del 1927, riesce ad animare il racconto espressionista della città declinato come una sinfonia di scene quotidiane, dai silenzi dell’alba alla febbrile vita serale. Aggiornando segni e parole, lo ha anche Wenders tra gli anni settanta e ottanta del Novecento: nel suo racconto urbano c’è ancora uno spazio onirico occupato dall’euforia e dal sogno. Lo faceva con più angoscia anche Ridley Scott, replicando, in scala gigantesca, le immagini di Sant’Elia. E oggi quale potrebbe essere il racconto della città? Al momento l’arte mi sembra silente su questi argomenti. (flp)