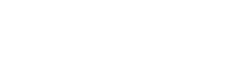- Aprile 26, 2017
Notizie
Libri – Polis. Costruire degli urban studies non chiusi nell’accademia
Giuseppe Scandurra insegna antropologia culturale e della comunicazione presso il dipartimento di st...Giuseppe Scandurra insegna antropologia culturale e della comunicazione presso il dipartimento di studi umanistici dell’università di Ferrara. È il direttore del Laboratorio di studi urbani dell’università di Ferrara e fa parte del gruppo di studio transdisciplinare Tracce urbane.
L’urbanizzazione. Il nostro pianeta sta sempre più urbanizzandosi: ormai, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di chi vive nelle città ha superato quello della popolazione rurale. E, se l’attuale tendenza sarà confermata, alla metà del secolo corrente circa i due terzi della popolazione vivrà in ambito urbano. Come valuti il fenomeno? Davvero “l’aria delle città rende liberi”?
Certamente, è un fatto nuovo, che per la prima volta si presenta nella storia del nostro Pianeta; e valutare un fenomeno “nuovo”, in corso, è sempre molto difficile per uno scienziato sociale. Occorrerebbe mettere in campo strumenti per un’antropologia processuale, quale quella che in altri periodi (vedi Scuola di Manchester) ha studiato il processo di urbanizzazione in Africa dopo il periodo coloniale e durante il processo di indipendenza (quando sono nate le prime grandi città africane, i primi sindacati, corpi intermedi, partiti ecc.); oppure recuperare uno sguardo alla “chicagoans”, quello che ha permesso a un gruppo di ricercatori e di etnografi di studiare come stavano “crescendo” le nascenti metropoli nordamericane nei primi anni del XX secolo.
Come d’altronde valutare un fenomeno laddove l’arrivo di tanti uomini e donne in città è frutto di molteplici ed eterogenee motivazioni (scelta, obbligo, migrazione forzata, sopravvivenza ecc.) e di diverse e contraddittore aspettative?
Inoltre, dietro questo dato se ne nascondono altri, di sicuro interesse analitico. La volontà di tanti “cittadini” e “cittadine” di abbondonare la città per vivere altrove (una minoranza, ma che tipo di minoranza?).
In sintesi, quello che è sicuro è che le nostri grandi città contemporanee (occidentali) dovrebbero essere al centro dei nostri studi (almeno nelle scienze sociali), poiché rappresentano luoghi di conflitto, palestre dove costruire un senso di identitià individuale e collettiva, spazi “nuovi” ma che si offrono sempre più a processi di ri-territorializzazione. In questa direzione è necessario, a mio parere, costruire (almeno nel nostro Paese) qualcosa che ancora non c’è: veri e propri urban studies che non racchiudano il sapere urbano dentro i confini disciplinari imposti dal nostro Ministero e dalle nostre Accademie.
La questione del limite. Negli anni ’20 Le Corbusier pensava la modernità come espansione, mezzo secolo dopo Insolera dice che la modernità è darsi un limite. Nella città immaginaria di Zoe (nelle Città invisibili di Calvino) priva di qualsiasi confine, interno ed esterno, si finisce con lo smarrirsi. Insomma ci vogliono i limiti e i confini (ammesso che si tratti della stessa cosa)?
Non so rispondere a questa domanda, poiché mi sfugge il concetto di “confine” e anche quello di “limite”. Non riesco a coglierlo se non dentro una visione metafisica, concettuale, attraverso uno sguardo postmoderno e un pensiero filosofico.
Inoltre, “ci vogliono” per chi? Non certo per chi vuole muoversi ed è protagonista di una migrazione forzata, immagino; o forse sì, credo, per chi ha bisogno di amministrare un territorio e renderlo vivibile per tutti i suoi cittadini e le sue cittadine.
Credo che i limiti e i confini siano “segni” spaziali fisici, non solo metaforici. Segni che determinano possibilità di inclusione e di esclusione, di vita e di morte in taluni casi. Il mar Mediterraneo non è, per quanto ci riguarda, il più grande (e vicino) confine che ci separa dal mondo arabo? E’ un limite? E’ un ponte? Cosa dovrebbe essere oggi?
Sarebbe interessante avviare (sempre in termini transdisciplinari) un grande studio (alcuni ce ne sono) sul senso che ricoprono per esempio i grandi muri (da Gerusalemme al Messico) che caratterizzano la nostra contemporaneità. Come sono vissuti da parte di chi li abita?
Il rapporto con il passato. Il rapporto con il passato, con le opere architettoniche del passato e i siti archeologici, è oscillante tra imbalsamazione e assenza di memoria: città come parco a tema per turisti, i Grandi Eventi come riverniciatura superficiale…Ad es. ritieni che il Comune dovrebbe salvare negozi e caffè di valore storico, come fanno a Parigi?)
Io sono nato a Roma (anche se non ci vivo più da tanto tempo); il passato, per me, come cittadino, è di conseguenza un “limite” poiché spesso è stato utilizzato politicamente per impedire determinati processi di trasformazione urbana. Oggi lavoro in una piccola cittadina che si chiama Ferrara che continua a dirsi (“chiacchiericcio” ancora presente nei bar del centro storico): “Nel 1500 Ferrara era New York”); ma cosa è successo a Ferrara negli ultimi seicento anni sembra non interessare molto a nessuno.
Non so dire se le “politiche” di salvaguardia del proprio patrimonio (“parigine”) debbano essere messe in campo anche altrove; a che servono? Come vengono percepite? Chi le ha ideate a cosa pensava?
Di sicuro il nostro rapporto con il passato e con il futuro è determinato anche dal nostro vissuto, dalle città che abbiamo conosciuto, da quelle che vedremo. Banalmente, non vedo possibilità di sopravvivenza per quanto concerne città costruire sul nulla (prive di sguardo al passato), ma non vedo vita nemmeno alle città che museificano ogni loro “patrimonio” a fini turistici. Ma come si construisce questo equilibrio (forse berlinese?) tra Passato e Futuro? Gli amministratori come vengono formati e si formano per rispondere a questa domanda?
La rappresentazione della città. Oggi occorre una nuova rappresentazione e un altro racconto per tentare di costruire una qualche idea comune e adeguata del vivere in città. Chi potrà costruirla? Urbanisti? Amministratori? Scrittori? Artisti? Sociologi?
Come detto in precedenza non vedo altra strada per studiare le nostre città se non quella di costruire dei veri e propri urban studies in un’ottica transdisciplinare. Per quanto concerne la rappresentazione di questi territori, credo che non esista solo la tecnologia della scrittura. Oggi sempre più scienziati sociali (anche se le università sono in forte ritardo su questo in Italia) fanno ricerca attraverso la macchina cinematografica e quella fotografica, rappresentano gli spazi urbani con mappe e cartografie nuove. Il nostro “sapere urbano”, inoltre, fino al secolo IXX è stato caratterizzato da un legame fortissimo tra letteratura scientifica e “fiction”. Solo con la nascita delle prime cattedre di sociologia e antropologia urbana questo legame è stato letteralmente “cestinato” a fronte di una costruzione di sapere positivistico, scientista ecc. Anche in questo senso il contributo di scrittori, artisti, letterati deve essere determinante e in continuo dialogo con quello degli studiosi urbani che hanno un’immaginazione più sociologica. (flp)