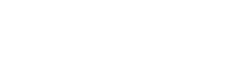- Aprile 18, 2017
Notizie
Libri – La città del grande raccordo anulare
Marco Pietrolucci, architetto, ha scritto La città del Grande Raccordo Anulare (Gangemi 2013)...Marco Pietrolucci, architetto, ha scritto La città del Grande Raccordo Anulare (Gangemi 2013).
Oggi è sotto attacco la città, e la democrazia che la sottende.
L’urbanizzazione. Il nostro pianeta sta sempre più urbanizzandosi: ormai, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di chi vive nelle città ha superato quello della popolazione rurale. E, se l’attuale tendenza sarà confermata, alla metà del secolo corrente circa i due terzi della popolazione vivrà in ambito urbano. Come valuti il fenomeno? Davvero “l’aria delle città rende liberi”?
Il fenomeno della crescita delle città e la loro trasformazione in metropoli o addirittura in megalopoli è un fenomeno di cui si discute da molti anni senza essere riusciti ad indicare una strategia di fondo che consenta di mettere in equilibrio dinamiche urbane e realtà rurali. C’è un bellissimo libro di R. Rogers Città per un piccolo pianeta che ha quasi vent’anni e che ancora descrive correttamente come le città possano tramutarsi da spazi di condivisione, di incontro e di scambio in agglomerati socialmente problematici che consumano le risorse del pianeta e rendono la vita miserevole. Le città, comunque, continuano ad essere il principale motore dell’economia sociale e in questo senso vanno continuate a studiare. Mi interessa però sottolineare un’ altra questione che a mio avviso è centrale per capire cosa è una città. Pensiamo per un momento a quanto sta succedendo nelle città siriane, Aleppo e Palmira, e in generale in tutta l’area mediorientale. Quello che accade ci insegna, in fondo, due cose: la città è tornata ad essere il centro della lotta politica (e militare); aggredire la città equivale ad una carneficina, significa aggredire la bellezza e l’unicità delle compresenze che la determinano. Quanto viviamo è in fondo, il massacro dell’ idea stessa di compresenza e quindi il massacro fisico e concettuale della città.Anche se la vita sul nostro pianeta è sempre più urbana nel senso che sempre maggiori quantità di persone scelgono di vivere nelle città, questo termine non connota più, nella concretezza avvilente degli agglomerati contemporanei, grandi spazi di vita realmente comune, piazze, viali, parchi, strade, grandi strutture collettive, nelle quali siano immediatamente riconoscibili i valori della civitas: tutto tende a rifluire all’interno, si spezza, rifiuta la condivisione si autoghetizza, cede alla violenza della separazione, riducendo drasticamente il valore fondativo del vivere in città che per sua natura vuole dire mettere in comune relazioni, stabilire ponti tra comunità diverse, creare insiemi eterogenei di elementi e di spazi, rendere possibile l’armonica compresenza delle diversità.
La questione del limite. Negli anni ’20 Le Corbusier pensava la modernità come espansione, mezzo secolo dopo Insolera dice che la modernità è darsi un limite. Nella città immaginaria di Zoe (nelle Città invisibili di Calvino) priva di qualsiasi confine, interno ed esterno, si finisce con lo smarrirsi. Insomma ci vogliono i limiti e i confini (ammesso che si tratti della stessa cosa)?
Non mi piace molto la parola confine perché rimanda ad una idea di potere e di autorità territoriale che mi pare regressiva e non corrispondente con la complessità della contemporaneità. Siamo di fronte ad uno spazio che come un elastico contiene processi di espansione e di contrazione sociale e politica nel quale, a grande velocità, sta avvenendo un totale rimescolamento dei valori della modernità. La crisi della contemporaneità è infatti una crisi a largo spettro: è entrata in crisi l’idea di sovranità popolare e di democrazia; è entrata in crisi la figura del cittadino e quella del lavoratore; è entrata in crisi l’idea stessa dell’inviolabilità dell’uomo che in forza della sua unicità fondamentale di corpo e spirito, possiede diritti inalienabili (primo fra tutti quello alla vita). Ciò che è sotto attacco è in questo senso proprio lo spazio della città e la democrazia che rappresenta con i suoi valori fondanti di condivisione e di compresenza. I limiti di cui parli, che servono al formarsi dell’identità, separando ma anche unendo ciò che è diverso, sono in questo momento una complessa piegatura barocca, un dentro e un fuori cangiante che facciamo fatica ad analizzare e rappresentare. Questo non significa che non esista un problema di struttura e di forma (che i limiti aiutano a mettere in chiaro). Personalmente ritengo che sia assolutamente necessario ritornare a parlare di forma urbana. Per molti anni non se n’è parlato come se, venendo a mancare la storica distinzione tra città e campagna non ci fosse più un problema di struttura e di forma da affrontare. Secondo me è molto sbagliato perché la forma urbana è un elemento fondamentale di riconoscibilità e identità delle comunità. Quando parlo di forma urbana parlo di quegli elementi che attraversano il tempo della costruzione urbana rimanendo stabili (o quantomeno più stabili degli altri).Da questo punto di vista i limiti sono elementi necessari a chiarire cosa vogliamo rimanga più stabile nel tempo.
Il rapporto con il passato. Il rapporto con il passato, con le opere architettoniche del passato e i siti archeologici, è oscillante tra imbalsamazione e assenza di memoria: città come parco a tema per turisti, i Grandi Eventi come riverniciatura superficiale… Ad es. ritieni che il Comune dovrebbe salvare negozi e caffè di valore storico, come fanno a Parigi?)
La memoria è qualcosa di fondamentale per capire chi siamo, a patto che non diventi una scusa per imbalsamare il territorio e per trasformare lo spazio vivo della città in un simulacro di se stessa. I romani potevano contare su Giano bifronte per osservare il futuro: a noi quel mondo di divinità è ormai precluso. La memoria deve avere un ruolo attivo e vivo nei continui processi di trasformazione a cui siamo sottoposti altrimenti non è utile alla comprensione della realtà e diventa una bugia, la rappresentazione di una natura morta. La questione della debolezza del progetto urbano moderno (che, nella sua fase eroica voleva fare tabula rasa delle memorie del passato) va affrontata, a mio avviso, in un ottica di riesame politico di quanto sta accadendo oggi, con un occhio molto vigile al passato. A me interessa sottolineare il punto di maggiore rottura con la tradizione urbana, quando guardo alla città contemporanea. Lo spazio dove ragionare e discutere, ovverosia lo spazio pubblico, che nelle città occidentali ha avuto sempre un ruolo strutturante, sia da un punto di vista fisico che simbolico, si è ristretto e tende a scomparire dall’orizzonte degli spazi urbani contemporanei, di pari passo all’atrofizzazione del discorso pubblico. Rispetto a questo tema, che ruolo può avere la conoscenza del passato e la memoria?Non è del tutto vero che la socialità contemporanea si è spostata negli outlet: una mappatura dei movimenti urbani di un cittadinoci consegnerebbe una geografia molto più complessa dei movimenti che compie dentro la città, in cui accanto all’outlet (una macchina da abitare decisamente ben organizzata), esistono spazi e strutture, anche minime, che restituiscono il senso di un appartenenza comune dove l’incontro, l’ibridazione, l’innesto la stratificazione si realizzano naturalmente. Sono i luoghi attivi della città: i mercati dove si va a fare la spesa; le scuole dove si portano i figli, i luoghi del lavoro, gli ospedali, i centri sportivi, le strutture e gli spazi informali della socialità di margine ancora non riconosciuta.Riaffermare la centralità di questi luoghi nella pratica del progetto urbano mi pare una questione essenziale che ha a che fare con la memoria cioè con il significato duraturo delle nostre città. Non si tratta di disegnare qualche piazza o di rimettere in sesto qualche strada o di conservare un parco archeologico ma di contribuire a riattivare le comunità locali. E’ una direzione che ho cercato di indicare in un mio recente studio “Verso la realizzazione delle microcittà di Roma” nel quale mi sono posto il problema di comerinsaldare in nuove unità amministrative e socialile comunità urbane di Roma contemporanea che si frammentano, a partire dai nuclei più svantaggiati, più esterni e meno strutturati delle città, ovverosia a partire dal grande deposito della contemporaneità. Si tratta di un vasto programma di riattivazione del ruolo della memoria, che riafferma la centralità dei temi sociali nella pratica del progetto urbano.
La rappresentazione della città. Oggi occorre una nuova rappresentazione e un altro racconto per tentare di costruire una qualche idea comune e adeguata del vivere in città. Chi potrà costruirla? Urbanisti? Amministratori? Scrittori? Artisti? Sociologi?
Recentemente Franco Purini ha dichiarato che la città è qualcosa di inconoscibile. La si può solo progettare e progettandola, conoscerla. Sono molto d’accordo con lui. Tutte le volte che parliamo di città(e di rappresentazione di città) dovremo porci questa domanda: quali sono gli eventi, soprattutto quelli piccoli, banali e quotidiani, che contribuiscono, a tratti e per parti, a ridefinire i luoghi delle nostre città come luoghi di compresenza armonica? Se consideriamo i luoghi e i territori come il sostrato su cui si depositano le identità comuni più stabili nel tempo, rimaniamo dentro al labirinto. Giriamo leggermente l’ottica e mettiamo (per un attimo) al centro l’evento: luoghi e territori sono spesso gli eventi in cui li identifichiamo. Se consideriamo il ribaltamento come un fatto temporaneo utile a mettere in chiaro geografie sommerse e a innescare il progetto di rigenerazione delle nostre città sulla base non delle identità più stabili e storicizzate ma sulle azioni e sugli eventi a noi contemporanei, il ribaltamento di senso apparirà come un ritorno all’esplorazione delle radici: di ciò che consideriamo luogo, di ciò che diventa luogo in forza di un attività comune e di un comune bisogno.Sono infatti gli eventi, grandi e piccoli, banali e quotidiani o, anche, (più raramente) monumentali ed eccezionali a determinare i luoghi contemporanei, a costruire le identità, sia quelle temporanee che quelle più stabili nel tempo. La città e la sua rappresentazione non può che essere l’insieme di questi luoghi concatenati tra di loro, nella vita di ciascuno, che ciascuno (scrittori, artisti, sociologi, architetti) con la propria sensibilità e competenza aiuta a chiarire. (flp)