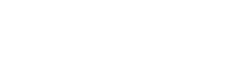- Febbraio 3, 2017
Notizie
Libri – Convergenze, solo di rado condivisioni, intervista a Roberto Carvelli
Carvelli, scrittore e giornalista - autore di vari libri su Roma - , ha creato un sito a...Carvelli, scrittore e giornalista – autore di vari libri su Roma – , ha creato un sito assai ricco e vivace – “Perdersi a Roma” – in cui raccoglie instancabilmente notizie, discorsi e narrazioni sulla città eterna.
L’urbanizzazione. Il nostro pianeta sta sempre più urbanizzandosi: ormai, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di chi vive nelle città ha superato quello della popolazione rurale. E, se l’attuale tendenza sarà confermata, alla metà del secolo corrente circa i due terzi della popolazione vivrà in ambito urbano. Come valuti il fenomeno? Davvero “l’aria delle città rende liberi”?
L’aria delle città non rende liberi. Piuttosto crea un sistema di convergenze – solo di rado condivisioni – che conforta – solo apparentemente – perché fraternizza – solo per poco. La realtà delle città è, in verità, fortemente intrisa di ruoli limitanti, talvolta schiavistici con o senza padroni riconoscibili. Il flusso dell’andare e del tornare, la sua dinamica, le sue attese, gli scontri. Il consumo e il rifiuto, il necessario stoccaggio di entrambi. La città vive di questi contenimenti e della loro forzatura. Gli stadi con sempre più anelli, le strade con più corsie, i centri commerciali sempre più grandi, i cassonetti sempre più capienti e/o diversificati. Contenimenti sempre più inefficaci che esondano. Le risorse disponibili, al contempo, diventano sempre minori o di minore qualità. Credere che questo sistema sia al punto di non ritorno vuol dire non aver ancora coscienza di quali vertici abbia raggiunto l’urbanizzazione nelle sue forme più complesse e corrotte. E di quanto forse ancora oltre possa giungere questo fenomeno. Se pure esistono risposte interessanti a questo collasso come il bioregionalismo e/o esperienze di organizzazione cittadina (cohousing, esperienze di comunità, hub lavorativi ecc.) sono però ancora troppo marginali. E meritano di essere sempre più diffuse e praticate anche in maniera apparentemente solo resistente.
La questione del limite. Negli anni ’20 Le Corbusier pensava la modernità come espansione, mezzo secolo dopo Insolera dice che la modernità è darsi un limite. Nella città immaginaria di Zoe (nelle Città invisibili di Calvino) priva di qualsiasi confine, interno ed esterno, si finisce con lo smarrirsi. Insomma ci vogliono i limiti e i confini (ammesso che si tratti della stessa cosa)?
Dire che i limiti sono di per sé un’opportunità è dire una magnifica teoria, vera ma "alta". Superare un limite significa avere strumenti per rendersi "illimitati" e la città non ne fornisce direttamente ai suoi abitanti. Neppure una grande parte della cultura ha a cuore di farli conoscere. Chi li offre li fa pagare spesso a caro prezzo per mantenere la stretta che giustifica l’urbanizzazione. Ma d’altro canto ognuno aspira a creare da sé la strada per questo superamento che è connessa alla cultura, all’educazione e alle risorse economiche ed è perciò limitata. L’essere umano tende naturalmente alla libertà, necessariamente quasi. Anche a scapito di altri. Passare con la macchina sulla corsia di emergenza, vampirizzare i cassonetti della spazzatura, il furto organizzato o spontaneo sono, ad esempio, un’altra delle forme possibili di autoliberazione. Mi viene in mente un film di qualche anno fa in cui il vero protagonista è un muro alto che separa rendendola impraticabile "La Zona" (questo il titolo della pellicola, il regista era Rodrigo Plà), un quartiere residenziale e iperlussuoso nella periferia di Città del Messico. Lo cito per dire che superare un limite non è sempre la soluzione – non lo è neppure crearlo, ovvio – se non per dei ragazzini attratti dal benessere come topi in una trappola. Spesso non lo è neppure il viaggio. E forse neppure la flanerie – l’esempio più nobile del superamento dei limiti della metropoli primo novecentesca occidentale – lo è per forza e sempre. Ma sono soluzioni utili nel breve, nel respiro del tempo. Ed è il tempo il discrimine di tante limitazioni anche se addomesticarlo non comporta da sé un salto di paradigma.
Il rapporto con il passato. Il rapporto con il passato, con le opere architettoniche del passato e i siti archeologici, è oscillante tra imbalsamazione e assenza di memoria: città come parco a tema per turisti, i Grandi Eventi come riverniciatura superficiale…Ad es. ritieni che il Comune dovrebbe salvare negozi e caffè di valore storico, come fanno a Parigi?)
Dovrà farlo. Avrebbe dovuto farlo già. Ha fatto bene quando e dove è riuscita a farlo. Questi interventi discriminano buone e cattive amministrazioni, riuscite o non riuscite urbanizzazioni. Anche se può irritarci la gentrificazione in qualche caso – e anche se, lo sappiamo, spesso con malizia economica – si è sostituita al cattivo uso della memoria. Ma stiamo parlando solo architettonicamente, è chiaro, di quartieri salvati dall’abbandono o dall’incuria senza che qualcuno mettesse la testa alla loro riqualificazione. Come non l’ha messa nella proliferazioni di periferie male organizzate e collegate.
La rappresentazione della città. Oggi occorre una nuova rappresentazione e un altro racconto per tentare di costruire una qualche idea comune e adeguata del vivere in città. Chi potrà costruirla? Urbanisti? Amministratori? Scrittori? Artisti? Sociologi?
Non vi è dubbio che la rappresentazione della città, la sua narrazione non potrà che essere – non potrà che esserlo di più – compito di artisti e scrittori. I sociologi – ma pure gli psicologi – potranno fornire invece elementi di più precisa lettura dei fenomeni che si verranno creando. Con elevata responsabilità di analisi. Ma il punto critico che avverto più pressante, oltre al necessario ascolto di queste voci "altre" rispetto al potere economico, è e sarà la necessità di un ragionamento urbanistico, la mancata fiducia nel pensiero onesto dei progettisti o la verifica del loro operare, attenta che non venga forzato solo verso l’ottimizzazione del risultato economico. Dovrà essere chiaro poi che i costi sociali di errori dovuti ad errate progettazioni andranno assorbiti e superati con responsabilità, non scaricati e sclerotizzati sui cittadini. Mi auguro poi che non si continuino a usare parole come utopia o utopistico riferite a questioni vitali almeno quanto anni fa a questioni teoriche. Un gioco delle parti molto triste. E assolutorio. (flp)