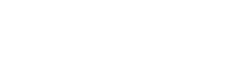- Febbraio 6, 2017
Notizie
Libri – Contro la frenesia urbanocentrica, intervista a Alessandro Pertosa
Alessandro Pertosa, che insegna filosofia e teologia a Macerata e simpatizza per il pensiero anarchi...Alessandro Pertosa, che insegna filosofia e teologia a Macerata e simpatizza per il pensiero anarchico non-violento, è autore di vari libri sul tema della decrescita felice. Citiamo solo il recente Solo una decrescita felice(selettiva e governata) può salvarci (Lindau Editore)
L’urbanizzazione. Il nostro pianeta sta sempre più urbanizzandosi: ormai, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di chi vive nelle città ha superato quello della popolazione rurale. E, se l’attuale tendenza sarà confermata, alla metà del secolo corrente circa i due terzi della popolazione vivrà in ambito urbano. Come valuti il fenomeno? Davvero “l’aria delle città rende liberi”?
No, non credo che l’aria della città renda liberi. Tutt’altro. Le concentrazioni nelle aree urbane, utili alla nuova civiltà industriale, hanno prodotto una trasformazione radicale dell’umanità occidentale. Perché, per dirla con Wittgenstein, se i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo, nel momento in cui trasformo il mondo, modifico anche il linguaggio, le parole, i significati, modifico me stesso e il modo in cui mi relaziono al contesto. Con l’urbanizzazione, i cittadini hanno smesso di abitare e hanno cominciato a risiedere. Abitare è un gesto comunitario; risiedere invece è un modo d’essere dell’appartato, di colui che se ne resta rintanato in casermoni ostili e respingenti. Mondo e linguaggio si contaminano a vicenda. E per convincersi basta pensare al significato che ormai attribuiamo all’aggettivo urbano. Di per sé, il termine è un prestito da latino urbanus, e in senso letterale significa soltanto appartenente alla città, cittadino. Ma la rapida affermazione della civiltà industriale ha prodotto una torsione semantica tale che da semplice cittadino, la voce urbanus ha finito per significare in senso metonimico la persona considerata civile, cortese, fine, che si oppone a quella rustica, villana, cafona, terrona, dei centri rurali, della campagna.
La società contemporanea sancisce così la supremazia della città sul villaggio, della metropoli sul paese, dell’agglomerato industriale sulla comunità conviviale. E l’homo urbanus, per convincersi e convincere i suoi simili della bontà di tale visione, finisce per bandire dall’immaginario culturale ogni riferimento alla vita agricola. Così tutto ciò che accade in città, o che in un certo qual modo ha a che fare con il ciclo produttivo di merci, viene visto con favore. E il linguaggio non può far altro che adeguarsi alla visione del mondo dominante, per cui gli atteggiamenti ritenuti civili diventano urbani, mentre al contrario quelli rozzi e incivili vengono qualificati come cafoni o contadineschi.
La questione del limite. Negli anni ’20 Le Corbusier pensava la modernità come espansione, mezzo secolo dopo Insolera dice che la modernità è darsi un limite. Nella città immaginaria di Zoe (nelle Città invisibili di Calvino) priva di qualsiasi confine, interno ed esterno, si finisce con lo smarrirsi. Insomma ci vogliono i limiti e i confini (ammesso che si tratti della stessa cosa)?
Confine e limite non sono sinonimi. Il confine è la gabbia che blinda, che separa terre, proprietà, esseri viventi. Il limite ha invece una dimensione spirituale. Lo abbiamo dentro, nel cuore e accende il nostro personale desiderio vitale di oltrepassarlo, con la consapevolezza però di non poterlo fare davvero; o meglio, di non poterlo superare del tutto. Allo stesso tempo, è importante provarci comunque a superarlo, è importante lanciare la sfida all’infinito, perché se questo desiderio smisurato manca, si finisce per annegare in un mare di futili bisogni. Il limite definisce quindi l’orizzonte oltre il quale continuiamo a guardare: sappiamo che l’al di là è irraggiungibile, ma ciononostante tendiamo comunque a raggiungerlo. Sull’importanza del limite e sul rischio che si corre quando si pretende di abitare la dismisura, potrei ricordare la lezione di Dante: Io è compagni eravam vecchi e tardi / quando venimmo a quella foce stretta / dov’Ercule segnò li suoi riguardi / acciò che l’uom più oltre non si metta. L’Ercole che è in noi non è l’ideologia o l’istituzione, ma la consapevolezza di riconoscersi finiti. E nel coglierci finiti scorgiamo anche il desiderio, l’esigenza, d’infinito. Ora, per tornare alle nostre città, io credo che Le Corbusier possa essere considerato l’urbanista ispiratore di Zoe; città spersonalizzata, dove le differenze sono state bandite, e diventa quindi impossibile distinguere il dentro dal fuori, il rumore delle ruote di un carro dall’ululato dei lupi. La diversità è data dal limite, e in questo senso è una ricchezza. Una città indistinta, priva di segni riconoscibili, è un luogo distopico da cui è impossibile uscire. E quante periferie delle nostre metropoli moderne sono anonime e spersonalizzate come Zoe?
Il rapporto con il passato. Il rapporto con il passato, con le opere architettoniche del passato e i siti archeologici, è oscillante tra imbalsamazione e assenza di memoria: città come parco a tema per turisti, i Grandi Eventi come riverniciatura superficiale…Ad es. ritieni che il Comune dovrebbe salvare negozi e caffè di valore storico, come fanno a Parigi?)
Credo sia fondamentale preservare la memoria. Perché chi non sa da dove viene, non può sapere dove andare. Ma preservare la memoria non significa imbalsamare il passato, né cedere a processi melensi e disgustosi di nostalgia. Pertanto distinguerei i Grandi Eventi, che servono esclusivamente al business e a quella che è stata giustamente definita «riverniciatura superficiale», dal recupero serio e rigoroso del proprio passato, necessario a progettare il futuro.
La rappresentazione della città. Oggi occorre una nuova rappresentazione e un altro racconto per tentare di costruire una qualche idea comune e adeguata del vivere in città. Chi potrà costruirla? Urbanisti? Amministratori? Scrittori? Artisti? Sociologi?
Ritorno al principio del mio ragionamento. Ogni trasformazione passa per il linguaggio. Per ricostruire la città è necessario elaborare nuove forme di sintassi comunitaria, che consentano a chi oggi si percepisce unicamente come cittadino residente, scisso e separato dal contesto, di cogliersi in forma nuova, di ritrovarsi abitatore di un luogo che lo costituisce. Questo, è chiaro, sempre che si voglia ripartire dall’uomo e dalla sua libertà. Per provare a smentire Caproni quando in modo molto netto sentenzia: – C’è più libertà in carcere o in città? / – Non ce n’è libertà. È carcere l’intera città…
Ma, a questo punto, se le città moderne sono diventate così invivibili, oltre a ripensarle urbanisticamente si dovrebbe forse mettere in discussione anche la concentrazione urbana. Davvero non si può vivere altrove? Io credo di sì. E dico di più: a dispetto della frenesia urbanocentrica che pervade ogni angolo bituminoso, il luogo a cui si ritorna ogni volta per strade sconosciute è proprio quello della provincia remota coi suoi ostinati campanili. Lì dove da secoli, da millenni, paesi stretti a scrigno fra mura uniche e polverose resistono ad oltranza, lasciandosi vivere addosso, senza frenesie, senza clamori. (flp)