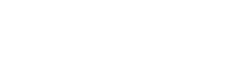- Aprile 14, 2016
Notizie
Immigrati – Qel Sole24Ore – Rifugiati, esperienze di accoglienza integrata di Italia e Germania a confronto in Slovenia
di Simone D'Antonio In numerosi paesi dell'Europa centrale e orientale la gestione dell'acc...di Simone D’Antonio
In numerosi paesi dell’Europa centrale e orientale la gestione dell’accoglienza dei rifugiati è ancora legata a situazioni di emergenza e all’apertura di centri incapaci di creare un legame con i territori in cui sono inseriti, contribuendo così a far percepire il fenomeno più come un rischio che come un’opportunità di sviluppo per l’intera comunità. Il confronto avviato da esperti, comuni e società civile in Slovenia, con la partecipazione attiva del governo nazionale, sta contribuendo negli ultimi mesi ad aumentare il livello di attenzione di media e opinione pubblica verso possibili modelli di successo da replicare in un paese che ospita al momento meno di 400 rifugiati.
Il modello della rete Sprar
L’esperienza italiana della rete Sprar (Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati) non colpisce solo per il numero crescente di posti dedicato all’accoglienza integrata in oltre 400 progetti (oltre 22mila al momento che diventeranno 27mila nei prossimi mesi) ma soprattutto per il coinvolgimento attivo delle comunità che accolgono, a partire dall’impegno forte dei sindaci e degli enti gestori provenienti dal mondo dell’associazionismo e del terzo settore. Rendere l’accoglienza un elemento di crescita per l’intero contesto locale è l’elemento caratterizzante dell’esperienza italiana soprattutto a confronto con l’estero, dove ci si scontra ancora con la diffidenza dei residenti anche in fase di reperimento delle strutture da destinare all’accoglienza. In Italia si è scelto strategicamente di non concentrare l’accoglienza in pochi, grandi centri ma di diffonderla sull’ intero territorio nazionale attraverso progetti spesso di piccole dimensioni, capaci di integrarsi al meglio nei territori e favorire uno scambio culturale e sociale costante con i residenti. Da queste politiche e da un accompagnamento costante da parte dei municipi, responsabili dei progetti e attori decisivi in una logica di governance multilivello sia nei confronti del governo centrale che verso la cittadinanza, derivano alcune tra le esperienze di maggiore successo realizzate all’interno della rete dello Sprar: esperienze che segnalano non solo la buona qualità delle azioni e delle partnership locali messe in campo ma anche un impatto positivo in termini occupazionali e di integrazione per i beneficiari.
Esperienze sul territorio
Ne è un esempio la startup Marameo creata su impulso del progetto Sprar di Canelli (Asti) per favorire l’inserimento lavorativo in agricoltura di un gruppo di rifugiati che si sono dedicati a colture biologiche testando modalità di impresa innovativa in una delle vocazioni tipiche del territorio. La promozione dell’agricoltura sostenibile si unisce alla promozione della legalità nel progetto Sprar di Valderice (Trapani), in cui il comune ha concesso l’utilizzo di terreni confiscati alla mafia per la realizzazione dell’iniziativa «I sapori dell’intercultura», che ha visto la partecipazione attiva dei rifugiati nella coltivazione di prodotti locali. Sul fronte dell’imprenditoria innovativa si distinguono le esperienze dell’Atelier Nuele promosso dai rifugiati del progetto Sprar di Santorso (Vicenza) per la produzione di accessori e abbigliamento, come anche del catering multietnico Tobilì realizzato a Napoli con la collaborazione di personale locale e rifugiati ospitati nel locale progetto Sprar. Il rafforzamento dei legami di comunità e il miglioramento della percezione dei rifugiati nell’opinione pubblica locale sono stati rispettivamente promossi dai progetti Sprar di Satriano (Catanzaro) e dal comune di Bologna, il primo con una serie di attività legate al rapporto tra anziani residenti e richiedenti asilo, il capoluogo emiliano con la campagna di comunicazione Bologna Cares, che ha promosso uno storytelling innovativo delle storie dei rifugiati locali e una forte sensibilizzazione della popolazione attraverso incontri e cene multietniche.
La strategia tedesca
Il riuso di spazi pubblici abbandonati per favorire al contempo accoglienza e rigenerazione urbana è invece la strategia scelta da numerosi comuni tedeschi, che hanno così rilanciato il dibattito sui benefici anche in termini spaziali e di recupero di pezzi di città derivanti dall’ accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo. Nella regione della Ruhr, la città di Oberhausen ha coinvolto urbanisti e creativi di diversi paesi europei nell’iniziativa Refugees for co-creative city, che sta favorendo la realizzazione di originali iniziative di recupero di spazi abbandonati, come la torre dell’orologio della locale stazione, attraverso il coinvolgimento dei rifugiati in fase di pianificazione e realizzazione e degli interventi. In quella che è la città con il più alto tasso di povertà della Germania, il coinvolgimento del tessuto associativo locale ha consentito di smussare all’origine ogni possibile forma di protesta da parte della popolazione locale, come invece avvenuto nella parte orientale del paese. Tale collaborazione ha consentito l’emergere di una serie di progetti paralleli, come la Refugees’Kitchen, container trasformato in food truck multietnico diventato in breve tempo punto di incontro mobile tra la comunità locale e i richiedenti asilo che hanno contribuito sia alla realizzazione tecnica dell’iniziativa che alla promozione delle proprie culture d’origine attraverso la gastronomia.