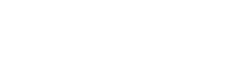- Ottobre 20, 2025
Istruzione
De Toni: “L’alleanza tra Comuni e Università è la chiave per lo sviluppo dei territori”
L'intervista al delegato Anci all'Università e Ricerca: “Ecosistemi di tirocinio per connettere studio e lavoro”
Il protocollo ANCI-CRUI rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare il legame tra il sistema universitario e le comunità locali. Attraverso la collaborazione tra Comuni e Atenei, è possibile promuovere una crescita equilibrata e sostenibile, capace di coniugare formazione, innovazione e coesione sociale. Le università diventano motori di sviluppo territoriale, contribuendo alla rigenerazione urbana e all’attrattività dei luoghi. Al tempo stesso, i Comuni si configurano come attori chiave nel sostegno alla vita studentesca e nell’accoglienza di giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un’alleanza strategica, dunque, per costruire città più inclusive, dinamiche e orientate al futuro. A raccontarlo per la rubrica “Parola al delegato” è Alberto De Toni, sindaco di Udine e delegato Anci all’Università e Ricerca.
Come il protocollo ANCI-CRUI può rafforzare il ruolo delle università nei Comuni, migliorare l’accoglienza studentesca e generare sviluppo locale?
Il protocollo ANCI-CRUI è uno strumento prezioso perché mette a sistema due realtà fondamentali: i Comuni, che rappresentano i territori e le comunità locali, e le Università, che formano il capitale umano del futuro. Favorire la presenza e il rafforzamento delle università nei Comuni significa innanzitutto migliorare la qualità della vita studentesca, attraverso l’aumento dei posti di accoglienza per fuori sede e stranieri. Questo non è solo un investimento infrastrutturale, ma un volano di sviluppo. Più studenti significano più vitalità economica per le imprese locali, più dinamismo culturale e più apertura internazionale. È un arricchimento reciproco: gli studenti trovano un contesto favorevole e le città crescono in attrattività e innovazione.
Come lo scambio di informazioni e buone pratiche tra università e amministrazioni comunali su tematiche come pianificazione urbana, sostenibilità e innovazione sociale può tradursi in progetti e strategie capaci di aumentare la competitività e l’attrattività dei territori?
Lo scambio di esperienze su temi come pianificazione urbana, sostenibilità e innovazione sociale permette di trasformare idee in progetti concreti. Penso, ad esempio, a strategie urbane integrate che nascono dall’apporto scientifico degli atenei e si traducono in soluzioni reali per la transizione ecologica, la mobilità sostenibile e la rigenerazione degli spazi urbani. In questo modo le città diventano veri e propri laboratori di sperimentazione, capaci di aumentare la competitività e l’attrattività dei territori, anche in chiave europea.
Quali iniziative ritiene prioritarie per favorire occupazione giovanile e tirocini attraverso la collaborazione tra università, imprese e amministrazioni locali, e che ruolo possono avere i giovani come protagonisti dello sviluppo dei territori?
Dobbiamo rendere sistemica la collaborazione tra università, imprese e amministrazioni locali. Immagino la creazione di veri e propri ecosistemi di tirocinio che connettano i percorsi di studio con le esigenze produttive e sociali del territorio. Le imprese possono beneficiare di giovani preparati e motivati, i giovani possono inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro, e le amministrazioni possono coordinare questo incontro. Ma soprattutto i giovani non devono essere solo destinatari di politiche: devono diventare protagonisti. Il loro contributo nei processi partecipativi, nei progetti di innovazione sociale, nelle startup e nel volontariato civico è parte integrante dello sviluppo dei territori.
Quali strumenti di monitoraggio e valutazione potrebbero essere introdotti per misurare l’efficacia delle collaborazioni tra università e Comuni in termini di sviluppo economico, culturale e sociale?
Per misurare l’efficacia della collaborazione tra università e Comuni occorrono strumenti chiari e condivisi. È fondamentale avere indicatori che permettano di valutare l’impatto economico, ad esempio in termini di posti di lavoro creati, nuove imprese e attrazione di investimenti. Un osservatorio congiunto ANCI-CRUI potrebbe raccogliere e comparare questi dati, così da indirizzare meglio le politiche future.
Sulla base della sua esperienza come professore, direttore scientifico e sindaco, quali auspicabili strategie e interventi ritiene prioritari per rafforzare il sistema dell’istruzione e il ruolo dei Comuni nel promuovere innovazione, coesione sociale e sviluppo dei territori?
La mia esperienza accademica e amministrativa mi porta a dire che oggi servono tre scelte fondamentali. Innanzitutto, bisogna investire nell’istruzione come infrastruttura sociale: scuole e università devono essere spazi aperti alle comunità, capaci di generare valore condiviso. In secondo luogo, è necessario promuovere la terza missione delle università, affinché la ricerca e la didattica si traducano in innovazione sociale ed economica. Infine, occorre rafforzare il ruolo dei Comuni come facilitatori di reti, mettendo insieme università, imprese, terzo settore e cittadini per co-progettare sviluppo, coesione e sostenibilità.
Udine è già impegnata in collaborazioni tra università e amministrazione su coesione sociale, attrattività territoriale e accoglienza studentesca: può illustrarci un progetto concreto e come questo modello potrebbe essere replicato a livello nazionale?
A Udine stiamo già sperimentando iniziative congiunte tra Comune e Università, in particolare nell’ambito turistico, culturale e nella condivisione del patrimonio storico e ambientale della città. Penso, ad esempio, ai progetti dedicati alle presenze turistiche, in particolare alla loro provenienza, intrapresi con il laboratorio di Geomatica dell’ateneo udinese. Una collaborazione che ci ha portato a analizzare meglio le presente turistiche in città, grazie ai dati delle celle telefoniche e alle analisi statistiche del laboratorio, durante periodi specifici come gli eventi natalizi. Ma sono molti anche i progetti che valorizzano i luoghi identitari, rendendoli spazi di fruizione non solo per i cittadini ma anche per gli studenti e i visitatori internazionali. In questo modo rafforziamo la funzione educativa e sociale dell’università e, al tempo stesso, custodiamo e rinnoviamo la memoria storica e il patrimonio ambientale del territorio. È un modello che può essere replicato a livello nazionale: ogni città universitaria può mettere a disposizione i propri beni culturali e paesaggistici, trasformandoli in leve di attrattività e coesione sociale, in un’alleanza virtuosa tra comunità locali e sistema universitario.