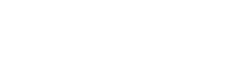- Febbraio 17, 2016
Notizie
Città metropolitane – QEL Sole24Ore, European metropolitan authorities forum: le aree metropolitane d’Europa a confronto
di Annalisa Gramigna (*) Venerdì 12 febbraio Torino ha ospitato <a href="http://w...di Annalisa Gramigna (*)
Venerdì 12 febbraio Torino ha ospitato il secondo Forum delle aree metropolitane europee che ha riunito gli amministratori di circa 30 aree metropolitane.
La Dichiarazione di Torino
È stata una giornata dedicata al confronto tra le esperienze delle città ma è stato anche un incontro fondativo che si è concluso con l’approvazione della Dichiarazione di Torino con la quale le città chiedono di essere «considerate interlocutori e partners fondamentali nell’elaborazione e realizzazione dell’Agenda urbana europea e chiediamo all’Unione europea di giungere rapidamente alla sua adozione e di assumere sempre di più le Città metropolitane come destinatari diretti dei fondi europei finalizzati alle politiche metropolitane» (punto 4 Dichiarazione di Torino).
Gli interventi di Fassino e Boch
Il Forum è stato aperto dall’intervento di Piero Fassino, sindaco di Torino, e da Alfred Boch, vice sindaco di Barcellona. Fassino ha evidenziato come la dimensione metropolitana sia sempre più centrale nello sviluppo delle nazioni e, riconoscendo che ogni Paese ha le sue specificità, ha focalizzato l’attenzione su alcuni elementi che accomunano le città metropolitane europee: il tema della crisi, l’inclusione sociale, gli interventi urbanistici, il tema della conoscenza, la cultura come fattore costitutivo al modello di sviluppo, gli investimenti per lo sviluppo. Questi aspetti, ha sottolineato Fassino, devono essere affrontati attraverso un’adeguata pianificazione strategica che articoli una strategia di medio-lungo periodo. Le sfide comuni che gli amministratori delle aree metropolitane devono affrontare sono la ragione per la quale le autorità metropolitane europee hanno deciso «di ricercare insieme soluzioni comuni, al di là delle specificità nazionali».
Anche secondo Alfred Boch, per poter far fronte alla crescita delle città e alla conseguente sfida della sostenibilità è necessaria una visione strategica. «Le città devono essere camminabili e vivibili», ha detto Boch, e ha aggiunto un elemento significativo: serve un disegno che consenta di creare un nuovo rapporto tra le aree fuori della città e le campagne. Questi processi di cambiamento devono essere sostenuti da adeguate risorse e su questo fronte due sono le considerazioni fatte: la prima è la necessità che le grandi città europee possano parlare direttamente con i decisori della Comunità europea per poter concordare l’orientamento delle risorse disponibili; la seconda riguarda l’organizzazione che le città si devono dare per governare in autonomia le risorse. Nel caso di Barcellona, per esempio, è stata costituita un’unica Autorità di coordinamento dei Fondi Ue che vengono distribuiti alle altre 35 città dell’area metropolitana.
Il ruolo chiave della politica "visionaria"
L’idea che la scala metropolitana sia quella adeguata per lo sviluppo non si mette più in discussione: «Sono le città che spingono l’economia» ha detto il professor Michael Parkinson – Direttore dell’Heseltin institute for public policy and practice (Università di Liverpool) – ed è per questo che i leader delle città dovranno sviluppare una nuova governance che tenga conto della dimensione locale, di quella nazionale e di quella europea. Lo sviluppo delle città metropolitane passa, secondo Parkinson, dalla creazione di nuovi modelli di intervento che partano dai bisogni ma sappiano anche cogliere e sostenere le opportunità; che sappiano definire e individuare i livelli territoriali giusti per gli interventi; dove si preveda il coinvolgimento strategico di vari attori (nazionali, europei e territoriali). E soprattutto c’è bisogno di una leadership visionaria.
Operare a livello metropolitano, però, è complesso per via della frammentazione e dei possibili conflitti tra i territori. Per questo «abbiamo bisogno di una nuova politica per creare vero consenso e nuovi valori». È la politica a dover giocare un ruolo-chiave dimostrando che le città metropolitane sono in grado di generare vantaggio anche per le piccole città e per i territori agricoli. Ci vuole tempo, ha detto Parkinson, e bisogna lavorare insieme per portare risultati che diffondano fiducia sui nuovi modelli di azione e sul ruolo delle aree metropolitane. È determinante, quindi, che i governi nazionali e l’Europa incentivino la collaborazione e la negoziazione. Ed è per questo che si deve chiedere all’Europa che i Programmi operino a livello di città e area metropolitana.
Patto di Amsterdam: rendere concreta l’Agenda urbana europea
A una maggiore autonomia delle città punta il Patto di Amsterdam, presentato da Nicolaas Beets, inviato speciale del Ministro degli Interni olandese che ha in carico l’Agenda urbana europea. Il Patto di Amsterdam intende adottare misure concrete per l’adozione dell’Agenda urbana europea attraverso la creazione di partnership e una governance multilivello. Le partnership sono create tra città, Europa e stakeholders.
L’intenzione è di poter dimostrare quanto prima una serie di modelli funzionanti attraverso progetti-pilota. Dal lavoro di queste partnership usciranno proposte per nuove normative, interventi sui processi e idee per lo sviluppo delle città. Le partnership sono dedicate a quattro temi: housing, qualità dell’aria; povertà; inclusione di migranti e rifugiati. Quest’ultimo progetto-pilota è coordinato da Amsterdam, quindi da una città e non da un Paese membro, con l’intento di comprendere cosa succede se il coordinamento avviene direttamente da parte di una città.
Per la creazione delle partnership sono stati sentiti diversi attori rilevanti (Urbac, Eurocities, il Comitato delle Regioni, Cemr, …) ai quali è stato chiesto di suggerire le città da coinvolgere. Dopo un percorso di consultazioni, incontri e momenti di confronto con tanti soggetti diversi, dai Paesi membri ai "city makers", si prevede di arrivare il 21 giugno alla presentazione del Patto di Amsterdam ma soprattutto alla sua approvazione da parte della Commissione europea.
Soluzioni metropolitane per strategia di governo e investimenti
Le città presenti si sono confrontate su alcune soluzioni adottate per l’attuazione delle strategie dei governi metropolitani. Da questo confronto sono emerse varie specificità soprattutto legate alle criticità contingenti e agli strumenti messi in campo ma sono emersi, altresì, degli interessanti tratti comuni che fanno riferimento, soprattutto, alla graduale capacità di collaborazione che i territori stanno imparando. Si tratta di un apprendimento che, spesso, è rafforzato dai risultati positivi ma, in genere, parte da una volontà politica forte che vede nella collaborazione un elemento di forza. Oltre all’importanza di una buona collaborazione tra i territori di una stessa area metropolitana (favorita dalla creazione di percorsi di ascolto degli attori pubblici e privati e dalla definizione coordinata di obiettivi e azioni) è emersa anche l’importanza dei "buoni rapporti" con il Governo nazionale. Nei casi come Budapest, dove la capitale ha un ruolo dominante, la soluzione è stata quella di puntare su una forte progettualità che aggreghi facilmente tutti e 23 i distretti dell’area metropolitana scegliendo iniziative che motivano l’aggregazione come la candidatura per i Campionati mondiali di nuoto del 2017. Altri due elementi sono rilevanti per l’efficace realizzazione della strategia di governo e gli investimenti: la presenza di personale adeguato e competente e la capacità di rappresentare ai cittadini la città metropolitana come forum e arena per lo sviluppo di progettualità che genera vantaggi per i cittadini stessi.
Capitali, città metropolitane e regioni
Più volte è emersa la questione del rapporto tra capitali, città metropolitane e enti territoriali sovraordinati come le regioni. In Italia questo è un tema rilevante che, come ha sottolineato Eugenio Comincini, vice sindaco di Milano, impatta sulla possibilità delle città metropolitane di programmare diverse politiche: dal trasporto pubblico alla pianificazione territoriale. Ma anche altre città hanno indicato in questa "concorrenza" istituzionale una criticità: in alcuni contesti è la capitale che pesa maggiormente e che influenza lo sviluppo di tutta l’area metropolitana (com’è accaduto a Marsiglia, per esempio), in altri contesti è il ruolo sovraordinato della regione che può "disturbare" l’azione della città metropolitana dimostrandosi lontana dalle istanze dei cittadini (come a Barcellona, per esempio). I presenti ritengono, però, che sia un errore far scattare il conflitto tra aree metropolitane e regioni perché esiste una "ragione superiore" che è l’interesse dei cittadini. A Barcellona, per esempio, la regione è economicamente più debole della città metropolitana ma la soluzione adottata è molto pratica: «la regione va aiutata soprattutto perché se la gente ha bisogno di un ospedale va fatto un ospedale, se serve una metropolitana la città deve avere la sua metropolitana». Questa posizione è confermata da Raffale Cattaneo, membro del Comitato delle regioni, che ha sostenuto che regioni e città metropolitane devono lavorare insieme e creare alleanze «per portarci sulla strada dello sviluppo».
La narrazione della città metropolitana per una nuova cittadinanza
Il tema della cittadinanza è stato introdotto da Pierre Monsant, Responsabile delle relazioni metropolitane presso Grand Paris, ma poi ripreso da molti altri: la dimensione metropolitana genera nei territori e nei cittadini una paura di fondo legata alla perdita di identità e al senso di inappartenenza. Questa paura va affrontata aprendo un dialogo e un confronto sull’opportunità di realizzare un progetto culturale che vada oltre i singoli territori attivando «nuove dinamiche e nuove speranze». La costruzione della "cittadinanza metropolitana" richiede di agire forme di partecipazione civica per evitare che questa istituzione sia troppo distante dai cittadini.
Enzo Bianco, sindaco di Catania, nel suo intervento sottolinea come sia necessario «riuscire a dare alle città metropolitane un’anima». Lione racconta del lavoro fatto su questo fronte attraverso la creazione di elementi simbolici, come il marchio della città che propone l’area metropolitana di Lione come un’idea unica di città verso tutti i suoi pubblici. Inoltre è stato creato un ufficio unico che è la "porta di accesso" a tutti i servizi offerti ai cittadini. Anche Bilbao sottolinea la necessità di coinvolgere le persone soprattutto quando si interviene all’interno dei quartieri, come è successo nel loro caso con interventi urbanistici di grande rilievo che hanno avuto impatti significativi sugli spazi pubblici e sulle abitudini di vita. Anche l’esperienza di Hannover evidenzia la necessità del "dialogo urbano" che, nel loro caso, è avvenuto attraverso eventi, forum online tematici e momenti di presentazione sullo stato dell’arte. Su questo punto è tornato nelle sue conclusioni anche il sindaco Fassino evidenziando la necessità di una nuova cultura della dimensione metropolitana e l’opportunità di creare una narrazione adeguata perché «nessuna riforma istituzionale può dipendere solo dall’esistenza di una norma».
(*) Area studi, ricerche e banca dati delle autonomie locali Anci