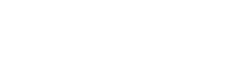- Luglio 16, 2018
Notizie
Avvistamenti – Respirare (di nuovo) a pieni polmoni. La Relazione e l’Ente Locale: una lectio preziosa di Giuseppe De Rita
Giovedì scorso nel piccolo auditorium Aldo Moro, via di Campo Marzio 24, &n...Giovedì scorso nel piccolo auditorium Aldo Moro, via di Campo Marzio 24, Giuseppe De Rita ha tenuto una lectio magistralis su “Evoluzione delle comunità e dei territori: il motore dello sviluppo italiano”. L’incontro è stato promosso e coordinato da Lucio D’Ubaldo, mentre la lectio è stata introdotta puntualmente dal sindaco di Ascoli Piceno e presidente Fondazione Ifel di Anci Guido Castelli.
Nelle parole di De Rita il racconto storico-critico del nostro paese, dalla Ricostruzione del dopoguerra fino alla crisi attuale, ha acquistato colori epici: sfilava davanti a noi una esaltante epopea nazionale, che ha come protagonista un popolo straordinario, prima laborioso, ottimista, progettuale, pieno di fiducia, e poi improvvisamente spento e come ripiegato su di sé. Con De Rita una disciplina come la sociologia diventa fascinosa, risolvendosi in una affabulazione vibrante, anche dai toni personali, piena di dati e di cifre. Impossibile riassumere la lectio. Mi limito a due o tre passaggi decisivi: la ripesa corale degli anni ’50, con una popolazione che voleva lo sviluppo, e con la Populorum progressio di Paolo VI che a quello sviluppo seppe dare una dimensione “spirituale”. Un paese che per vari decenni, e pur attraverso una conflittualità sociale anche aspra, ha saputo produrre ricchezza in tutti i settori (specie attraverso i protagonismi locali, i distretti industriali, il territorio, etc.: tema congeniale al fondatore del Censis): “si respirava a pieni polmoni”. Dal’inizio del terzo millennio invece si notano i segni di un rattrappimento, anche come riflesso della crisi planetaria: si riscopre la sobrietà, quasi una “austerità” coatta, e con il celebre “vaffa” viene sancita la rottura della relazione. Certo, bisognerebbe indagare se questa relazione fosse già seriamente incrinata prima, magari dalla seconda modernizzazione (anni ’80), ma la diagnosi di De Rita ha colpito per la sua severità e radicalità. Che fare? Occorre recuperare il senso della complessità, che i Tramp e i miopi costruttori di muri sembrano obliterare, ritrovare fiducia nel futuro, rimettere al centro l’ente locale, e soprattutto ricostruire ovunque la “relazione” (tra i cittadini, tra il cittadino e l’istituzione).
Al discorso lucido e appassionato di De Rita aggiungo solo due ordini di considerazioni, che ho potuto svolgere velocemente al piccolo auditorium. Anzitutto una che riguarda la mia disciplina, il mio campo di interessi, su cui la riscoperta del localismo ha avuto importanti ripercussioni: la storiografia letteraria. Dal 1967 la storiografia letteraria non è più la stessa di prima. E sapete perché? A partire dal 1967 nelle storie letterarie da quel momento è entrata la geografia, il territorio, la comunità e la lingua locale. L’autore di questa rivoluzione storiografica è Carlo Dionisotti (scomparso nel 1998), che già nel 1951 aveva avuto la sua straordinaria intuizione sulla letteratura italiana, e cioè che la grande storia letteraria di De Sanctis (1871) si rivelava ora inadeguata, perché dava pochissimo spazio al carattere policentrico della nostra tradizione culturale. E poi: l’accento sui comuni, sui localismi e sui territori (evoluzione degli antichi distretti), e poi sulla manifattura, e – aggiungo – una certa disposizione caparbiamente “positiva” che percorre la lettura di de Rita del nostro paese, la sua attenzione alla “orizzontalità del sommerso”, sono una felice reazione a certo autolesionismo che prevale proprio negli studi umanistici. Il repertorio della nostra tendenza autodenigratoria è sterminato, e non privo di fondamento (assenza di senso civico, ricatto di lobby e corporazioni, assistenzialismo parassitario, infiltrazione della criminalità organizzata, etc.), ma non si parla mai dell’altro lato della medaglia: seconda industria manifatturiera in Europa, primo posto nel volontariato civile, e soprattutto capacità di esportare una immagine scintillante di modernità possibile (una modernità plurale, contraddittoria, e però sostenibile: il Made in Italy è il terzo brand più noto al mondo, dopo Coca-Cola e Visa)!Una forza simbolica non solo rivolta al passato, legata cioè a patrimonio artistico e bellezza naturale, ma che nasce dalla traduzione di quel passato in uno stile di vita moderno e desiderabile (tra moda, design, cibo, musica, cinema…).
De Rita, riferendosi agli anni ’50, ha parlato di sviluppo e di progresso (citato quest’ultimo dal papa). Pasolini in uno dei suoi interventi alla fine degli anni ’60, volle distinguere tra sviluppo e progresso, tra sviluppo economico e tecnologico e progresso morale e civile. Non sempre coincidono, e anzi non bisognerebbe mai perdere di vista il nesso che invece dovrebbe unirli. Dunque riprendiamo e valorizziamo l’anima del nostro peculiare sviluppo, della nostra crescita – e cioè il rapporto con il territorio e con le comunità – e proprio da qui proviamo a immaginare un progresso, una evoluzione civile. Si tratta di riacquistare il gusto di quello che Dante chiamava il “ben fare”, il quale tende a generare sempre la relazione con l’altro, proprio come auspicato da De Rita. Dopo cinquant’anni abbiamo, forse, la possibilità di far coincidere di nuovo progresso e sviluppo, e di respirare di nuovo a pieni polmoni. (flp)