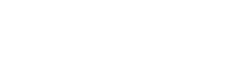- Marzo 12, 2018
Notizie
Avvistamenti – Le buone pratiche e Dante
Si parla sempre più spesso di buone pratiche di cittadinanza, e cioè di esperienze -&n...Si parla sempre più spesso di buone pratiche di cittadinanza, e cioè di esperienze – prevalentemente dal basso – di democrazia partecipata, di rigenerazione di beni comuni nelle città, di pratiche amministrative fondate sulla trasparenza, di orti urbani, di riduzioni di spreco di risorse, di pratiche di accoglienza, di volontariato, di servizi di mediazione linguistica, etc. Non è, evidentemente, l’antipolitica, ma l’espansione di una idea di politica diversa da quella strettamente partitica e più istituzionale, e ad essa necessaria, perché fondata sull’intreccio tra società civile e istituzioni. Si tratta di un’area ampia, variegata che si potrebbe riunire sotto l’etichetta del “ben fare”. Ma da dove nasce questa espressione? Probabilmente da Dante, è dunque ben radicata nella nostra tradizione. “Ben far”: questa espressione nella Commedia ricorre più volte, in Inferno, nel canto VI, in Purgatorio, nel canto XVIII, in Paradiso nel canto VI ((il canto VI di ogni cantica è un canto politico). E’ l’agire utile alla polis. Non basta però dichiararlo. Si riconosce perché dà realtà agli altri, fa esistere la comunità nella sua interezza, senza cancellarne o espellerne una parte. All’inferno Ciacco, che si trova dentro il girone dei golosi, risponde a Dante che chiedeva notizie di Farinata, Arrigo e “li altri ch’a ben far puoser li ’ngegni” (cioè che si impegnarono nell’azione civile e politica) e apprende che si trovano più in basso nell’inferno, tra “le anime più nere”. Dunque non basta la politica, o la scelta di fare politica, per salvarsi. La politica va ispirata da qualcos’altro, che non è la politica stessa. Il ben fare deve essere illuminato da una dedizione sincera, altrimenti può divenire un alibi, e si riduce a una continua ricerca di cariche pubbliche, come accade nella invettiva finale – dopo quella celebre contro l’Italia (“ahi serva Italia…”) contro Firenze del canto VI del Purgatorio (ci troviamo ancora nell’antipurgatorio) dove il poeta (cioè l’autore, non Dante personaggio) si rivolge, alla propria città con dolente ironia. Prima dice ai fiorentini che se altri popoli hanno la giustizia in cuore ma non sempre sulle labbra, invece loro ce l’hanno “in sommo de la bocca” (e dunque non nel cuore). Poi aggiunge che molti rifiutano le cariche politiche ( e sono gli stessi che hanno la giustizia nel cuore) mentre a Firenze tutti smaniano per averle anche quando non gli vengono proposte: “Molti rifiutan lo comune incarco; /ma il popol tuo solicito risponde /sanza chiamare, e grida: ‘I’ mi sobbarco!’”). E’ come se Dante ci suggerisse che il ben fare ha una concretezza che privilegia il raccoglimento, l’attenzione alla realtà, la prossimità a una dimensione civica tangibile. (fl)