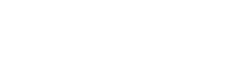- Luglio 11, 2025
Immigrazione
Asilo, D’Alberto: “Rete Sai è patrimonio per Paese, Comuni centrali per il Patto Ue su migrazione”
Il sindaco di Teramo e delegato all’Immigrazione e alle politiche per l’integrazione e l’accoglienza: “La presa in carico dei Msna è divenuta sempre più gravosa per i Comuni in ragione anche dalle mutate situazioni dei minori che arrivano nel nostro Paese”
I numeri della rete Sai, ma anche la costruzione del nuovo Patto Europeo sulla migrazione e l’asilo che deve vedere i Comuni protagonisti e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Sono questi alcuni temi di cui abbiamo discusso con Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo e delegato all’Immigrazione e alle politiche per l’integrazione e l’accoglienza.
È stato pubblicato il Rapporto annuale SAI XXIII edizione. Quale è il bilancio 2024 del sistema di accoglienza e integrazione?
Dopo 23 anni, il SAI continua ad essere il sistema di accoglienza e integrazione per eccellenza dei cittadini di Paesi terzi che chiedono asilo in Italia. Un sistema che, come dimostrano i numeri dell’ultimo Rapporto coinvolge circa 2.000 Comuni – quasi il 25% dei Comuni italiani ne è parte – tra cui quasi tutti i Comuni sopra i 100.000 abitanti e più di 1.000 Comuni piccoli e piccolissimi. Questo dimostra l’impegno dei Comuni, insieme al privato sociale, nel farsi carico delle 55.000 persone accolte nel SAI nel 2024, provando a costruire per loro ma anche per le comunità che accolgono, prospettive di futuro. Tutto ciò non sarebbe possibile senza il lavoro di oltre 25mila operatori, professionisti del pubblico e del terzo settore che ogni giorno seguono direttamente e da vicino i percorsi di integrazione degli accolti. Il bilancio quindi è assolutamente positivo. Come ha dichiarato il Presidente Manfredi, il SAI ha costruito, e continua a farlo, un patrimonio infrastrutturale, professionale e sociale che dai territori, piccoli e grandi Comuni, viene messo a disposizione dell’intero Paese. Un patrimonio che oggi, come ho avuto modo di sottolineare in più occasioni, è sempre più strategico, soprattutto in un tempo in cui le emergenze umanitarie sono sempre più numerose e destinate ad aumentare, anche a causa di un quadro geopolitico internazionale sempre più precario e in cui il tema dell’accoglienza e dell’integrazione ci chiama tutti a responsabilità. Si tratta infatti di coniugare la doverosa tutela dei diritti umani, a partire dal diritto alla vita, con la necessità di garantire la coesione delle nostre città.
Nella Prefazione al Rapporto lei parla di “febbre di crescenza”. Ci spiega cosa intende dire?
I dati del Rapporto 2024 confermano che il SAI permane e continua a crescere: è di fatto una delle politiche pubbliche nazionali più radicate e longeve. Tuttavia, permangono aspetti di criticità che mantengono la rete in una condizione di precarietà: si pensi alle continue modifiche dei profili giuridici degli accoglibili, alla parcellizzazione dei fondi da cui vengono individuate le risorse per finanziare la rete, così come la crescente complessità della presa in carico degli accolti.
Tutto questo però credo che sia parte di un percorso di crescita del sistema, sia in termini numerici che in termini di impegno: dobbiamo prepararci a nuove responsabilità, che diventano opportunità se colte appieno e se accompagnate da una nuova consapevolezza: partendo dal SAI e intorno ad esso è necessario far convergere ulteriori opportunità che, con finanziamenti provenienti anche da altri fondi e in un’ottica di complementarità, sappiano rafforzare i percorsi di autonomia e di sviluppo, tanto dei beneficiari dei SAI quanto delle comunità tutte.
Per fare questo occorre un rapporto organico tra tutti i livelli istituzionali, con un intervento multilivello dove ciascuno è chiamato a svolgere la propria parte, considerate le competenze specifiche di ognuno e con particolare riferimento alla necessità di coinvolgere a pieno regime anche le Regioni, che troppo spesso rappresentano l’anello mancante nella filiera delle politiche per l’integrazione. È infatti necessario consolidare ogni opportunità di alleanza con tutti gli attori pubblici portatori di competenze e funzioni negli ambiti che più direttamente incidono con i percorsi di autonomia e sviluppo: dalla salute all’abitare, dall’apprendimento della lingua alla formazione professionale.
Il nuovo Patto Europeo sulla migrazione e l’asilo lancia una nuova e importante sfida per il vecchio continente. In cosa i Comuni italiani potranno contribuire alla sua implementazione?
Tra le diverse disposizioni del Patto Europeo, sicuramente ricopre un ruolo importante la nuova Direttiva (UE) 2024/1346 sulle condizioni di accoglienza, che avrà ricadute dirette sui sistemi nazionali di accoglienza e integrazione, compreso ovviamente il SAI. La Direttiva definisce standard di accoglienza uniformi in tutta l’UE, garantendo per i richiedenti asilo, non solo quelli vulnerabili, un livello di vita adeguato, con accesso effettivo ad alloggi, sanità, formazione e lavoro, in condizioni dignitose e comparabili tra i diversi Stati membri, a cui dunque l’Italia si dovrà adeguare, a nostro avviso, nella direzione di consentire al SAI di tornare ad accogliere tutti i richiedenti asilo. C’è un dialogo molto proficuo con il Ministero dell’interno su questo, che anzi colgo l’occasione per ringraziare, nella direzione di cogliere l’opportunità dell’adeguamento al Patto Europeo per investire sempre più sul rafforzamento del segmento SAI e sulla sempre maggiore specializzazione della seconda accoglienza.
Da qualche giorno insieme al Presidente Manfredi ha firmato una lettera indirizzata ai ministri Piantedosi e Giorgetti. Cosa sta accadendo sui territori circa i MSNA e come si è evoluta la loro presa in carico in questi anni?
La lettera firmata insieme al Presidente Manfredi è stata necessaria per rappresentare la preoccupazione di molti Comuni italiani che non stanno vedendo arrivare le risorse per l’assistenza e la presa in carico di minori stranieri soli. Risorse che negli anni scorsi sono state sempre garantite, a fronte di un tema come quello dei MSNA su cui ci sono indubbie competenze statali. Chiaramente al tema delle risorse si aggiunge quella della presa in carico, che in questi anni è divenuta sempre più gravosa, dettata anche dalle mutate situazioni dei minori che arrivano nel nostro Paese. Siamo di fronte ad un’accresciuta fragilità psico-sociale e a sempre più chiare evidenze di coinvolgimento in reti di tratta e sfruttamento. Le caratteristiche dei percorsi migratori appaiono diverse da quelle di alcuni anni fa, in cui il “progetto migratorio” dei ragazzi e delle loro famiglie appariva più fortemente orientato alla piena integrazione nel tessuto sociale italiano.
Esprimo tutta la mia gratitudine alle educatrici e agli educatori delle strutture che lavorano con i ragazzi, compiendo un lavoro preziosissimo che non verrà mai riconosciuto abbastanza.
Sul tema della gestione dell’integrazione porta avanti insieme all’amministrazione centrale altre importanti progettualità, come LGNet e InCaS. Come si connettono queste progettualità con ciò che i Comuni già svolgono sui loro territori a partire dal SAI?
Da un lato, si tratta della cosiddetta “terza accoglienza”, cioè quel supporto che è indispensabile per portare a compimento un percorso di piena inclusione che non sempre è possibile concludere nei tempi dell’accoglienza in SAI. Lo abbiamo fatto molto con le risorse dell’8 per mille e lo facciamo molto con LGNET, che coinvolge tutte le grandi città e che, attraverso fondi FAMI pluriennali, ha dato ai Comuni strumenti in più di grande rilevanza, a partire dalla complessissima questione abitativa.
Anche INCAS è molto importante, rappresentando un’alleanza molto stretta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per rafforzare l’engagement dei Comuni sul tema dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. Anche questo è un tema molto sfidante e che incide sullo sviluppo di un territorio nel suo complesso, a partire da quello dei lavoratori ma non solo, su cui davvero occorre attivare tutte le energie possibili.
Insieme alla Fondazione Cittalia, che è l’articolazione interna di ANCI che si occupa delle tematiche migratorie, cerchiamo sempre di impostare le progettazioni in modo da poterle capitalizzare il più possibile in termini di capacità di risposta ai bisogni “urgenti” che le città ci rappresentano; in termini di innovatività di approccio – vedere i fenomeni, i problemi e le risposte con occhi nuovi –; in termini di potenzialità di diventare azioni di sistema e strutturali.
Parlando molto spesso con i Comuni appare evidente come molte amministrazioni locali abbiano ormai impostato un metodo di lavoro sinergico e strutturato, tant’è che sono sempre di più i Comuni stessi i protagonisti dei percorsi formativi che proponiamo. Il modo in cui i Comuni stanno sviluppando capacità di visione e di management non solo nell’utilizzo complementare ed efficiente delle risorse, ma anche nel pensiero organizzativo che orienta la coprogettazione dei servizi comunali con la società civile organizzata ci parla di un cambio di passo di grande interesse, che sta anche a noi valorizzare e accompagnare.