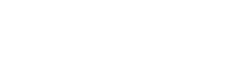- Giugno 16, 2017
Notizie
Libri – Polis. Intervista ad Alfredo Alietti
"Ci occorre il concorso dei diversi sguardi". Alfredo Alietti è professore aggreg..."Ci occorre il concorso dei diversi sguardi".
Alfredo Alietti è professore aggregato in Sociologia Urbana e del Territorio presso l’Università di Ferrara.
L’urbanizzazione. Il nostro pianeta sta sempre più urbanizzandosi: ormai, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di chi vive nelle città ha superato quello della popolazione rurale. E, se l’attuale tendenza sarà confermata, alla metà del secolo corrente circa i due terzi della popolazione vivrà in ambito urbano. Come valuti il fenomeno? Davvero “l’aria delle città rende liberi”?
Per valutare il processo di urbanizzazione planetaria bisogna innanzitutto considerare le differenze profonde tra il nord e il sud del mondo. Nel primo caso, Europa in particolare, la città non ha raggiunto le dimensioni e le visibili distorsioni presenti nelle “città freak” del sud. Di conseguenza, vi è ancora nelle grandi aree urbane europee un carattere emancipativo, per quanto sia indebolito dai processi di differenziazione socio-spaziale. Infatti, l’erodersi dei regimi di welfare i quali rappresentavano il risultato della conflittualità urbana dell’epoca fordista, i famosi “!trent’anni gloriosi”, associato ai mutamenti sociali ed economici della globalizzazione ha alimentato una dinamica di segregazione delle classi e dei gruppi vulnerabili (immigrati ed autoctoni) e delle classi più abbienti. In tal senso, il carattere attuale della città europea nelle sue diversi declinazioni si orienta su un modello sempre più marcato da una distanza sul piano sociale, politico, culturale e spaziale tra queste due polarità che disegna una sorta di arcipelago che attraverso il tessuto urbano. Nondimeno, le città europee rappresentano ancora il luogo del conflitto e delle chance di cittadinanza multiculturale. Il problema si situa nella banale constatazione che l’urbanità è, da sempre, sinonimo di diversità e che è la politica che sostiene con la sua azione pubblica la convivenza e riduce le distorsioni del neoliberismo.
La questione del limite. Negli anni ’20 Le Corbusier pensava la modernità come espansione, mezzo secolo dopo Insolera dice che la modernità è darsi un limite. Nella città immaginaria di Zoe (nelle Città invisibili di Calvino) priva di qualsiasi confine, interno ed esterno, si finisce con lo smarrirsi. Insomma ci vogliono i limiti e i confini (ammesso che si tratti della stessa cosa)?
La domanda sui limiti dell’urbano raffigura la domanda sulla questione del modello di sviluppo nell’epoca del neoliberismo. E’ chiaro che attualmente il regime economico urbano si connota con l’idea di regionalismo, ovvero di un’espansione della trama urbana apparentemente senza limite. Il diffuso sprawl nelle principali aree metropolitane in Europa diviene il paradigma empirico di una realtà in continua trasformazione. SI costituisce una “rete di reti di città” entro cui si strutturano processi di densità urbana ma anche di centro produttivi che segnano il territorio in maniera irreversibile.Nel caso delle megalopoli asiatiche, africane e latino americane il discorso muta in profondità. Si evidenzia la scomparsa del concetto di confine urbano così come si è discusso a partire dal XX secolo. La crescita dell’urbanità senza governo in questi casi rende visibile la metafora urbana di Italo Calvino dello “smarrimento” inteso quale carattere pervasivo di produzione di disuguaglianze e povertà.Di conseguenza, limiti e/o confini quali sinonimi del riconoscimento della città sta perdendo progressivamente di significato nei due contesti di riferimento pur nella loro profonda differenza e strutturazione urbana. Sulla base di questa realtà vi è la necessità di ripensare lo stesso significato di limite all’espansione urbana e comprendere quali siano gli strumenti di governo di un’entità spaziale e geografica difficilmente contenibile.
Il rapporto con il passato. Il rapporto con il passato, con le opere architettoniche del passato e i siti archeologici, è oscillante tra imbalsamazione e assenza di memoria: città come parco a tema per turisti, i Grandi Eventi come riverniciatura superficiale…Ad es. ritieni che il Comune dovrebbe salvare negozi e caffè di valore storico, come fanno a Parigi?)
La città è diventata la nuova centralità dell’economia mondiale. La competitività urbana tra le principali metropoli in Europa alimenta dinamiche collegate all’attrattività degli investimenti in cui un ruolo determinante si collega al turismo e alla produzione dei grandi eventi. Al di là dell’analisi fattuale degli effetti di tali fenomeni su scala urbana, è indubbio che una parte significativa di questa strategia riguarda il recupero di quello che la Zukin chiama “autenticità” dei luoghi. In questo orizzonte il passato, la memoria dei luoghi storici si inserisce nella logica di offerta di un’esperienza unica per il viaggiatore contemporaneo. La conseguenza di ciò è, spesso, la riqualificazione di questi spazi attraverso la gentrification e, quindi, il risultato di espellere quei soggetti che li vivono e li connotano. L’esito è un simulacro storico che è funzionale agli interessi del capitale fondiario che altera le relazioni tra i diversi gruppi sociali e gli spazi pubblici.
Questo non significa che il recupero della memoria dei luoghi non debba essere perseguita, anzi. Il problema, ancor auna volta, riguarda la capacità amministrativa di intervenire nel trovare l’equilibrio tra diritto alla città degli abitanti e alle esigenze di sviluppo economico e produttivo.
La rappresentazione della città. Oggi occorre una nuova rappresentazione e un altro racconto per tentare di costruire una qualche idea comune e adeguata del vivere in città. Chi potrà costruirla? Urbanisti? Amministratori? Scrittori? Artisti? Sociologi?
La città contemporanea nella sua molteplice morfologia spaziale, nella sua pluralità delle appartenenze, nella sua differenziazione sociale, nella sua variabilità tra centro e periferia non è più immaginabile, pensabile e, soprattutto, comprensibile senza il concorso e la condivisione dei diversi sguardi. Vi è l’urgenza di integrare le narrazioni e le visioni ad esse soggiacenti che nascono dentro la singolarità delle esperienze di analisi, studio e intervento sulla città.
L’interazione tra le discipline è l’unico percorso possibile per delineare il futuro delle metropoli in grado di reagire alle sfide della progressiva disuguaglianza socio-economica, della povertà, dell’insostenibilità ecologica e del cambiamento climatico. Se la frammentazione, la polarizzazione tra “città dei ricchi e la città dei poveri” è il segno con cui ci si deve confrontare la ricerca di una possibile interazione tra i saperi sembra l’unica strada percorribile per aumentare la capacità di governare le contraddizioni emergenti e di decifrare la complessità della vita urbana. (flp)