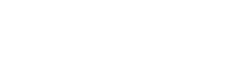- Aprile 10, 2017
Notizie
Libri – Polis, Tanto il limite ci viene imposto dal pianeta, intervista a Marco D’Eramo
Marco D’Eramo è un giornalista e saggista, interessato in particolare al tema del...Marco D’Eramo è un giornalista e saggista, interessato in particolare al tema della città: tra i suoi molti libri ricordiamo Il maiale e il grattacielo (Feltrinelli 1995) e Lo sciamano in elicottero (Feltrinelli 1999)
Il nostro pianeta sta sempre più urbanizzandosi: ormai, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di chi vive nelle città ha superato quello della popolazione rurale. E, se l’attuale tendenza sarà confermata, alla metà del secolo corrente circa i due terzi della popolazione vivrà in ambito urbano. Come valuti il fenomeno? Davvero “l’aria delle città rende liberi”?
Non è vero che più della metà della popolazione vive in città. Diciamo che meno di metà della popolazione vive “nella natura” (qualunque cosa questa espressione romantica voglia dire). Le interminabili sequenze di casermoni e di dormitori sono forse “città”? Li definirei piuttosto come “campagna edificata”. È il grande equivoco di tutte le teorizzazioni sulla “città diffusa” (il Veneto, la cosiddetta “città adriatica”): quella sterminata successione di villette e palazzine distanziate tra loro non è città diffusa, è solitudine agreste senza agricoltura, ad alta cementificazione e a media densità abitativa.
In Corea del sud dove lo spazio è poco e la densità di popolazione è alta, in piena campagna i paesi sono edificati con due-tre-quattro palazzoni di venti piani addossati l’uno all’altro e circondati dai boschi e dalle risaie, per risparmiare spazio che sarebbe divorato da casette più basse o addirittura unifamiliari come negli Stati uniti o in Siberia dove appunto la relazione con lo spazio è del tutto diversa. In Corea del sud vige perciò un ambientalismo high rise per così dire, ma quei palazzoni non li chiamerei “città”.
Se restringiamo la definizione di città al suo significato più profondo che la concepisce come non solo luogo di scambio, di comunicazione, d’incrocio (la “piazza”), ma come un prodotto tecnologico complesso che produce esso stesso scambio, comunicazione, dialogo, allora non è vero che più della metà della popolazione mondiale vive in città. Ed è ancora vero che, definita in questo senso, Die Stadtmachtfrei.
Negli anni ’20 Le Corbusier pensava la modernità come espansione, mezzo secolo dopo Insolera dice che la modernità è darsi un limite. Nella città immaginaria di Zoe (nelle Città invisibili di Calvino) priva di qualsiasi confine, interno ed esterno, si finisce con lo smarrirsi. Insomma ci vogliono i limiti e i confini (ammesso che si tratti della stessa cosa)?
Per fortuna, o per sfortuna, la terra è rotonda, quindi la questione del limite non ce la dobbiamo porre noi, ci viene posta dal nostro pianeta. Il modello tradizionale di urbansprawl è messo in crisi da molteplici fattori, tra l’altro i nuovi strumenti di comunicazione e di scambio (si torna sempre a quel punto): per esempio l’e-commerce produce una crisi irreversibile nel modello shopping center, mall, e quindi di tutta la concezione di vita suburbana che a esso è connessa: nel ‘900 le tecnologie comunicative erano, per così dire, segreganti: ti mettevano in comunicazione col mondo sì, a patto però che ti rinchiudessi a casa tua. Potevi ascoltare musica, ma sul giradischi del tuo salotto, potevi vedere film o pièces teatrali ma nel televisore o nelle videocassette: era l’idea dell’alloggio-astronave, in cui ti rinchiudevi per vivere il mondo: per assistere a eventi sociali ti ritiravi nella tua casa suburbana da cui esploravi il pianeta telefonicamente, televisivamente, con tutti gli strumenti di riproduzione.
Invece le nuove tecnologie sono portatili, mobili, nomadi. Puoi vedere un film o una partita senza dover più stare a casa tua, idem per ascoltare un concerto e parlare con amici vicini o lontani. Il mondo che prima ti ricreavi nel chiuso della tua casa ora te lo porti letteralmente dietro. Ed è questo nomadismo che fa rinascere i centri città, i luoghi di incontro e di scambio, le nuove “piazze”. Le abitazioni possono espandersi a perdita d’occhio a causa dell’accrescimento della popolazione, ma i gangli d’interazione umana, le città, si stanno rilocalizzando.
Il rapporto con il passato, con le opere architettoniche del passato e i siti archeologici, è oscillante tra imbalsamazione e assenza di memoria: città come parco a tema per turisti, i Grandi Eventi come riverniciatura superficiale…Ad es. ritieni che il Comune dovrebbe salvare negozi e caffè di valore storico, come fanno a Parigi?)
Ho scritto in parecchie sediduri attacchi contro i patrimoni dell’umanità dell’Unesco: li ho definiti “urbanicidi a fin di bene”. Il punto è che a noi tutti piace vivere in una città dove ci siano musei, monumenti, dove ci sia passato. Ma a nessuno di noi piace vivere in un museo, o nella sua foresteria. La città-museo muore, perché è imbalsamata è soggetta a tassidermia urbana. Il problema non è mantenere il passato o distruggerlo, è come trovare un nuovo modo presente per usare il passato. Se un vecchio caffè è ancora un buon caffè, ben venga il mantenerlo. La grande studiosa del patrimonio (e sua acerrima critica) FrançoiseChoay indica come uso particolarmente fruttifero e appropriato dei monumenti l’idea italiana di adibire edifici rinascimentali o medievali a sede di istituti universitari, centri studi, biblioteche: non luoghi chiusi e morti che vanno visitati pagando un biglietto, ma sedi di attività di vita.
Oggi occorre una nuova rappresentazione e un altro racconto per tentare di costruire una qualche idea comune e adeguata del vivere in città. Chi potrà costruirla? Urbanisti? Amministratori? Scrittori? Artisti? Sociologi?
Ripartiamo da Giambattista Vico: al loro inizio le grandi narrazioni sono sempre popolari, collettive: un’epica anonima. A costruire la narrazione di una città sono i suoi abitanti. Una certa idea di Parigi, che poi è stata veicolata dalle canzoni di Edith Piaf, Yves Montand, Boris Vian, è emersa dalla vita quotidiana dei parigini, dalla medievale vita universitaria degli Abelardo e dei François Villon, dai parigini che hanno vinto e perso quattro rivoluzioni nel giro di un secolo (1789-1871), e poi ancora altre nel XX secolo. La nuova città ce la rappresenteranno i cittadini di domani.
La novità della città che si delinea davanti a noi è che essa è multidimensionale (due persone sedute l’una accanto all’altra possono essere lontanissime nella loro testa, perché l’una ascolta i Nirvana e l’altra parla con un amico a Novosibirsk). È una situazione urbana totalmente inedita, per cui non abbiamo ancora né le parole né i concetti. L’unica cosa di cui sono sicuro è che non saranno certo gli amministratori a fornirceli. Saranno già bravissimi se potranno percepire l’aria del tempo e interpretarla, come fece negli anni ’80 Renato Nicolini. (flp)