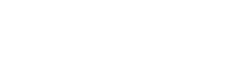- Marzo 3, 2017
Notizie
Libri – Polis, Distinguere tra confini e limiti
Intervista a Daniela Fonti, storica dell’arte Daniela Fonti ha insegnato alla Sapienza &ndash...Intervista a Daniela Fonti, storica dell’arte
Daniela Fonti ha insegnato alla Sapienza – facoltà di Architettura – Storia dell’arte contemporanea, ha ideato e diretto il primo master per curatori di mostre d’arte, e ha pubblicato vari saggi.
L’urbanizzazione. Il nostro pianeta sta sempre più urbanizzandosi: ormai, per la prima volta nella storia dell’umanità, il numero di chi vive nelle città ha superato quello della popolazione rurale. E, se l’attuale tendenza sarà confermata, alla metà del secolo corrente circa i due terzi della popolazione vivrà in ambito urbano. Come valuti il fenomeno? Davvero “l’aria delle città rende liberi”?
Difficile concentrare in poche righe la sterminata letteratura sul fenomeno dell’urbanizzazione, le cui interpretazioni sono abbastanza unanimi;.storicamente il fenomeno, almeno in Europa, si è accelerato con l’avvento della seconda rivoluzione industriale e con l’applicazione delle scoperte scientifiche al vivere quotidiano. La concentrazione delle industrie che richiamano in città una popolazione di operai e strappano mani alla campagna è già alla base delle analisi di Marx e Engels.ma ovviamente la popolazione della città non è solo operaia, ma si distribuisce per zone, con la concentrazione locale di diversi strati sociali. I flussi che regolano gli spostamenti e la divisione per zone dei diversi ceti sono alla base della costituzione della forma delle metropoli moderne. Cosa vuol dire “rendere liberi “?.Agli inizi del secolo XX l’elettrificazione delle strade nelle città rendeva gli uomini ma ancor più le donne, liberi dal pericolo delle aggressioni di fatto duplicando il tempo utile di fruizione dello spazio urbano, prima concentrato nelle ore diurne. Oggi tutto questo appare preistoria, mentre l’aggettivo “libero” ha assunto connotazioni sociologiche, nel senso della liberazione dell’individuo dal controllo sociale. Ma allora perché, secondo le statistiche, la dimensione dei piccoli centri, dove il controllo sociale è maggiore rispetto alle metropoli, garantisce una maggiore vivibilità ?
La questione del limite. Negli anni ’20 Le Corbusier pensava la modernità come espansione, mezzo secolo dopo Insolera dice che la modernità è darsi un limite. Nella città immaginaria di Zoe (nelle Città invisibili di Calvino) priva di qualsiasi confine, interno ed esterno, si finisce con lo smarrirsi. Insomma ci vogliono i limiti e i confini (ammesso che si tratti della stessa cosa)?
Limiti e confini non sono la stessa cosa e non rinviano agli stessi concetti. Il confine riguarda essenzialmente la natura fisica della città, in antico la cinta delle mura urbane, e oggi in un certo senso allude a quella cintura spaziale nella quale l’agglomerazione urbana si dirada fino a lasciare progressivamente spazio alla natura. La questione del limite, che chiama in campo le amministrazioni della città, postula una misura al di là della quale riesce assai più difficile la gestione del territorio.
Il rapporto con il passato. Il rapporto con il passato, con le opere architettoniche del passato e i siti archeologici, è oscillante tra imbalsamazione e assenza di memoria: città come parco a tema per turisti, i Grandi Eventi come riverniciatura superficiale…Ad es. ritieni che il Comune dovrebbe salvare negozi e caffè di valore storico, come fanno a Parigi?)
Ancora una volta occorre distinguere fra le azioni di valorizzazione del passato architettonico poste in essere dalle grandi metropoli e quelle adottate dai piccoli centri; le strategie rivelatesi valide per la piccola zona archeologica, ad esempio, possono non funzionare per le grandi città o per Roma, che, credo, ha il più esteso insieme di siti archeologici urbani del mondo. Spesso le azioni di salvaguardia sono intimamente connesse alle decisioni urbanistiche, come la creazione di zone pedonalizzate ma, ancora una volta, quello che può rivelarsi utile per una città storica italiana di medie dimensioni risulta poco praticabile per la metropoli. Da decenni a Roma si discute sul Parco Archeologico centrale che include l’area dei Fori da piazza Venezia fino al Colosseo, una vera spina nevralgica della città, anche in termini di collegamenti…; una sua totale rescissione dalla dinamica dei flussi urbani rischierebbe di trasformarla- per le molte ore dopo il tramonto- in una sorta di “deserto” mettendo a rischio la stessa qualità di vita delle aree periferiche “di bordo” intensamente residenziali. Insomma, le strategie, a mio avviso, debbono essere di volta in volta estremamente circostanziali e pertinenti e non sottostare ad astratti modelli ideologici.
La rappresentazione della città. Oggi occorre una nuova rappresentazione e un altro racconto per tentare di costruire una qualche idea comune e adeguata del vivere in città. Chi potrà costruirla? Urbanisti? Amministratori? Scrittori? Artisti? Sociologi?
Se per rappresentazione s’intende la costruzione di un modello del vivere urbano valido per tutti, nemmeno lo sforzo sovrumano e congiunto di tutte le figure citate nella domanda potrà riuscire nell’impresa. Più probabile invece, raggiungere qualche modesto – e precario – risultato, se non si ha la pretesa di avere le soluzioni in tasca, ma si torna modestamente a coniugare la riflessione teorica con l’ascolto degli “Steakholders”. (flp)