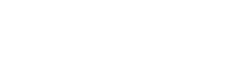- Settembre 9, 2016
Notizie
Libri – Avvistamenti,”Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del Gusto”
di Filippo La Porta Sicuri che “agnolotti” e “ravioli” indichino ...di Filippo La Porta
Sicuri che “agnolotti” e “ravioli” indichino la stessa pietanza? In alcune regioni sì, ma in altre no, e anzi i primi sono quelli riempiti con carne, e secondi senza. E’ uscita ora, a cura dello studioso Massimo Arcangeli, e con l’ausilio di una schiera di giovani allievi (e la collaborazione della Dante Alighieri) una storia linguistica dell’Italia alimentare, che individua 100 parole del gusto italiano, corrispondenti a una straordinaria varietà di regioni e idiomi, con riferimenti letterari alti o alla cultura pop (dal Gattopardo a Luisa Corna, da Michelangelo a Luca Barbareschi, da Omero a Bennato, da Ela Weber alla polenta del manzoniano Renzo, da Gadda a Carla Fracci…). Il catalogo è sterminato: si va da “arancino” a “cavatelli”, da “babà” a “ciauscolo”, da “caponata” a “saltimbocca”, da “farinata” a “pizzoccheri”, da “cannederli” a “savoiardi”, da “cantucci” a alla “pastiera”, dalla “fonduta” alla “salama” dai “brigidini” ai “taralli”, da i “mostaccioli” agli “struffoli”, dal “caciocavallo”alla “’nduja”, dal “cannolo” alla “sfogliatella”, etc., e si fanno alcune sfiziose scoperte. Ad es i “pici”, nome recente (1931, Guida del Touring) per un piatto antico, e cioè un impasto di farina e grano duro, acqua e sale, lavorato a forma di spaghetti grossolani, sono cucinati in modi diversi a seconda della regione e ogni volta assumono diversi “geosinonimi”: “stringozzi”, “umbricelli”, “lunghetti”… ( molto simili agli “strozzapreti”, che compaiono anche in un sonetto di Belli). Eppure nell’Italia dei mille campanili e dei diecimila dialetti curiosamente i nomi locali del confetto sono spesso simili fra loro: dal siciliano “cunfetta” al napoletano “cunfiette”, dal pugliese “cumbitte” all’abruzzese “cumbette”, dal “cunfeto” marchigiano al “confet” friulano. Soffermiamoci su due voci, le più nazional-popolari, “piazza” e “maccheroni”. La prima parola, di origine napoletana, è polisemica: a Roma si dice “che pizza!” nel senso di “che noia!”, ma si tratta dell’italianismo più diffuso nel mondo (in almeno 60 lingue!), ed è simbolo della cucina napoletana : Primo Levi osservava che a tutte le latitudini si incontra un napoletano che fa la pizza e un biellese che fa i muri (anche se Levi non poteva prevedere la massiccia immigrazione di egiziani piazzaioli!). E la “pizza margherita” doveva onorare la prima regina d’Italia, Margherita di Savoia. Quanto ai “maccheroni”, già presenti nel Decameron. Massimo Arcangeli, a cura di, Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del Gusto, Rubbettino, pp.404, euro 19